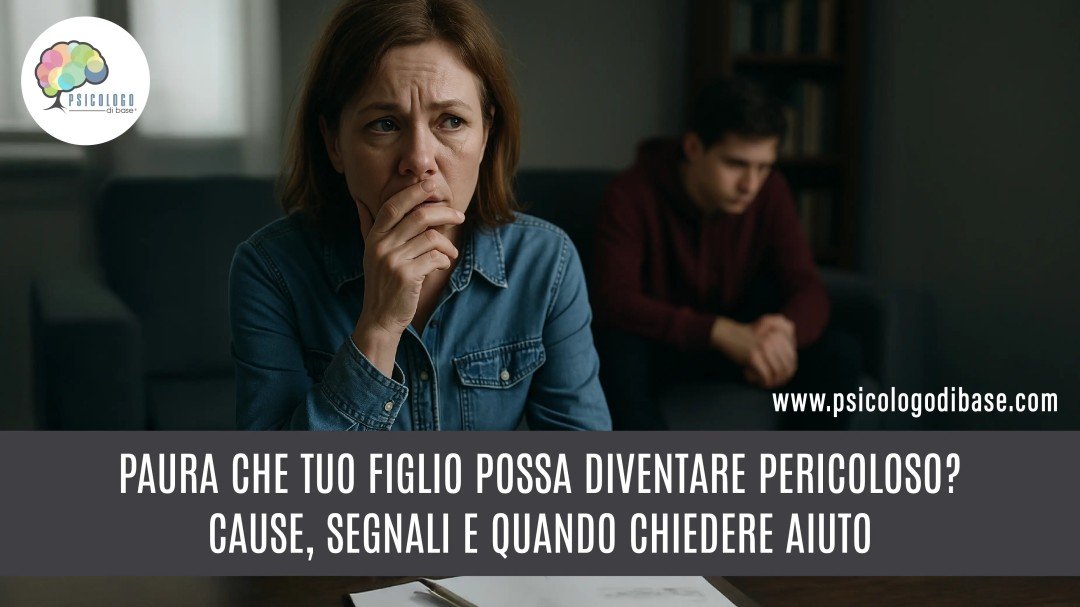- Perché ho paura che mio figlio possa farmi del male dopo i fatti di cronaca?
- Quali sono le cause psicologiche e familiari che possono portare un figlio a uccidere la madre?
- È colpa mia se mio figlio è diventato aggressivo o pericoloso?
- Come riconoscere i segnali di un figlio violento e cosa fare se rifiuta l’aiuto psicologico?
- Come prevenire la violenza in famiglia e rafforzare il legame madre-figlio?
- Come gestire l’ansia e la paura di essere aggredita dal proprio figlio?
- Domande frequenti delle madri che temono per la propria sicurezza
- Temere che tuo figlio possa diventare pericoloso è comprensibile: riconoscere i segnali è il primo passo.
Sei davanti al telegiornale, una tazza di caffè tra le mani, e sullo schermo scorrono immagini di una madre uccisa dal proprio figlio. Le parole sono forti, i titoli gridano all'orrore. E dentro di te qualcosa si muove: un pensiero improvviso, quasi inconfessabile. Potrebbe succedere anche a me?
Se hai provato questa paura, sappi che non sei sola: continua a leggere e scoprirai che la sensazione di smarrimento è comune a molti genitori ma potrai anche distinguere tra realtà e suggestione, e acquisire strumenti concreti e rassicuranti per riconoscere i segnali di un disagio in famiglia. Sei qui per comprendere. E soprattutto per ritrovare calma e fiducia nel legame con tuo figlio.
Perché ho paura che mio figlio possa farmi del male dopo i fatti di cronaca?
In che modo la cronaca nera influenza la percezione del pericolo in famiglia?
I media, soprattutto in seguito a episodi tragici, tendono a concentrarsi su narrazioni forti, emotivamente coinvolgenti anche per tenere lo spettatore incollato allo schermo. Quando vedi più servizi di fila su figli che uccidono le madri, il cervello inizia a elaborare quei fatti come più frequenti e vicini di quanto siano in realtà. Questo fenomeno ha un nome: availability heuristic, cioè la tendenza a valutare la probabilità di un evento in base alla sua disponibilità nella nostra memoria. Il bombardamento mediatico crea una percezione amplificata del rischio. In altre parole, inizi a sentire come possibile anche ciò che è statisticamente raro. Ed è umano: il cervello cerca di proteggerti, anche esagerando i segnali di pericolo.
Ti senti spesso in ansia e non sai se la tua paura è fondata?
Parlarne con uno psicologo può aiutarti a distinguere tra pensieri e realtà, senza sentirti giudicata.
Come capire se la mia paura di mio figlio è reale o indotta dai media?
Chiediti: Ho davvero notato comportamenti che mi fanno sentire in pericolo? O la mia ansia nasce soprattutto dopo aver ascoltato le notizie?
Segnali da monitorare:
- uso eccessivo di sostanze o alcol
- comportamenti distruttivi o minacce
- aggressività verbale frequente o incontrollata
- isolamento marcato e improvviso
- segni di autolesionismo.
Se questi segnali non sono presenti, è probabile che la tua paura sia frutto di ansia e sovraesposizione alla cronaca. Ricorda: provare paura non significa che ci sia un pericolo reale, un pensiero talvolta può sembrare reale ma è pur sempre solo frutto del nostro cervello e tale dobbiamo considerarlo.
Quali sono le cause psicologiche e familiari che possono portare un figlio a uccidere la madre?
Quali disturbi mentali sono associati ai casi di omicidio familiare?
In alcuni casi estremi, chi compie atti violenti all'interno della famiglia soffre di disturbi psichiatrici gravi, come il disturbo borderline e schizofrenia che possono portare a comportamenti estremi.
La storia di cronaca e il seguito giudiziario ci ha portato a concludere che questi disturbi possono allontanare la persona dalla realtà a tal punto da accettare di compiere questi atti. È fondamentale sottolineare, tuttavia che la maggior parte delle persone con queste diagnosi non è pericolosa. Il rischio aumenta solo in presenza di fattori concomitanti come isolamento sociale, mancanza di trattamento e storia di violenze precedenti. Questi stessi fattori possono, se protratti nel tempo, indurre anche soggetti che non presentano questi disturbi a compiere atti violenti: sono rari, ma la cronaca nera ne ha memoria, i casi di “parricidio riparatore”, in cui il figlio agisce contro il genitore che ha abusato dei membri della famiglia per anni o il cosiddetto “delitto liberatorio” in cui il figlio sviluppa una visione distorta della realtà in cui i genitori diventano l'ostacolo al raggiungimento della felicità e per questo devono essere eliminati (molto spesso i fattori economici, per esempio una cospicua eredità, possono influire in modo incisivo su questi comportamenti violenti).
Qual è il ruolo di traumi e relazioni tossiche nella violenza tra figli e genitori?
Molti studi, come quelli presentati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mostrano che la violenza in famiglia nasce spesso da contesti prolungati di trascuratezza, silenzio emotivo o conflitti cronici, e da relazioni tossiche con personalità narcisistiche. Non si tratta di un singolo litigio, ma di relazioni disfunzionali che, nel tempo, possono generare rabbia, frustrazione e rottura del legame affettivo. Un figlio che cresce senza sentirsi ascoltato o riconosciuto può sviluppare emozioni incontrollate, soprattutto se mancano modelli di gestione emotiva.
Perché spesso la violenza in famiglia nasce da più fattori combinati?
Non c'è mai una sola causa. È come una torta riuscita male: non dipende solo da un ingrediente, ma da un insieme di fattori che si combinano nel tempo.
Nella maggior parte dei casi di violenza familiare troviamo:
- Vulnerabilità psicologiche individuali
- Relazioni familiari conflittuali
- Eventi traumatici
- Assenza di supporto sociale
Comprendere questa complessità aiuta a non semplificare e a non colpevolizzarsi inutilmente. La famiglia da sempre costituisce un contesto che svolge molte funzioni per i figli: vediamo alcune.
In primo luogo la famiglia è un canale di comunicazione normativa: sin da bambini, in famiglia apprendiamo le regole da rispettare, i comportamenti da evitare. Se questo contesto rientra in una sottocultura deviante orientata alla violenza, è molto probabile che i valori che verranno trasmessi saranno di tipo negativo. È altrettanto vero che molte famiglie che vivono in contesti sociali e culturali disagiati, riescono a svolgere una funzione di filtro e trasmettere ai figli valori positivi orientati al rispetto delle regole.
In secondo luogo in famiglia si soddisfano, sin dall'infanzia, i bisogni non solo primari di sopravvivenza ma anche emotivi ed affettivi: la gratificazione affettiva e il senso di sicurezza che proviamo nel nostro nucleo familiare aiuta a sviluppare la personalità in modo armonico e quindi equilibrato. Attenzione all'iperprotezione che, contrariamente a quanto si possa credere, può favorire il mantenimento di una condizione di immaturità che, nel lungo termine, rende più difficile accettare le frustrazioni e quindi provocare disadattamenti comportamentali.
Infine in famiglia si sperimentano i primi processi di identificazione con i genitori: i figli assumono comportamenti e valori dei genitori come propri sviluppando una coscienza morale più o meno positiva e orientata all'altro e non solo a se stessi.
È colpa mia se mio figlio è diventato aggressivo o pericoloso?
Perché tante madri si sentono responsabili per i comportamenti violenti dei figli?
È naturale. Come madre, ti sei presa cura di tuo figlio fin dalla nascita. Se oggi ti appare distante, aggressivo o irriconoscibile, il primo pensiero è: Ho sbagliato qualcosa? Questo senso di colpa è umano, ma spesso ingiustificato. Non sei onnipotente. Anche se hai commesso errori, come ogni genitore, il comportamento di tuo figlio dipende da molti altri fattori, interni ed esterni. Potrebbe essere d’aiuto una consulenza psicologica.
Fino a che punto la madre è responsabile per il comportamento del figlio?
Il ruolo educativo è fondamentale, ma ha dei limiti. Una madre può offrire amore, regole e valori, ma non può decidere per un figlio adulto, né impedirgli di compiere scelte dannose. Oltre a quelli sopra elencati, uno dei ruoli dei genitori è quello di essere una sorta di “agenzia di controllo sociale”: la vigilanza, i premi, le punizioni, le gratificazioni fornite ai figli in relazione al loro comportamento possono plasmare il comportamento favorendo anche una capacità di socializzazione armoniosa ed equilibrata. L'autorevolezza in famiglia è uno strumento prezioso per crescere in modo sano i figli ma non deve diventare autoritarismo né portare a credere che sia l'unico fattore a determinare il futuro comportamento dei figli. Assumersi le proprie responsabilità è sano. Ma caricare tutto sulle proprie spalle è dannoso e irrealistico.
Come riconoscere i segnali di un figlio violento e cosa fare se rifiuta l’aiuto psicologico?
Quali comportamenti indicano che un figlio può diventare pericoloso?
Presta attenzione a:
- Isolamento estremo
- Esplosioni di rabbia frequenti
- Minacce verbali o fisiche
- Crudeltà verso animali o persone
- Uso di sostanze psicoattive
- Rifiuto costante del dialogo
- Deliri o convinzioni distorte della realtà
La presenza di più segnali, sempre contestualizzati nell'ambiente sociale e culturale che frequenta il figlio, è ciò che merita attenzione, non un singolo comportamento isolato.
Cosa posso fare se mio figlio rifiuta lo psicologo o ogni tipo di aiuto?
Di fronte a un figlio che non vuole cercare o ricevere aiuto per i suoi comportamenti preoccupanti non sei impotente. Ecco alcune strategie che puoi subito adottare:
- Crea uno spazio di ascolto, senza giudizio: l'ascolto attivo, ovvero orientato a comprendere realmente ciò che l'altro vuole comunicarci può aiutare i nostri figli a non sentirsi isolati e non compresi. Usando frasi come "Mi preoccupo per te", anziché "Devi farti aiutare", è possibile aprire uno spiraglio per un dialogo che permetterà al figlio di sentirsi ascoltato e non giudicato e a noi genitori di percepire la nostra presenza come effettivamente utile e importante per loro.
- Proponi un incontro con il medico di base: se la prospettiva di rivolgersi a uno psicologo potrebbe incontrare delle resistenze dovute allo pregiudizio che “solo i pazzi vanno dallo psicologo”, proporre una visita dal medico di base può essere più facilmente accettata. Il medico di base potrà poi persuadere il ragazzo a intraprendere il percorso più adatto per aiutarlo a superare le difficoltà che sta vivendo.
- Considera la presa in carico indiretta: rivolgerti prima tu a uno specialista può avere il duplice vantaggio di sapere come comportarti con tuo figlio in presenza di comportamenti inaspettati e, nello stesso tempo, può fornire un modello di azione a cui ispirarsi, per tuo figlio, spingendolo magari a riconsiderare l'iniziale rifiuto categorico di un aiuto esterno.
- Coinvolgi altri familiari, insegnanti o figure significative: dopo aver ragguagliato queste figure importanti, sulla situazione (magari condividendo questo articolo), potresti chiedere a loro di parlare con tuo figlio e cercare di comprendere cosa non va e come vorrebbe essere aiutato in questo momento difficile.
A chi rivolgersi se si ha paura del proprio figlio?
Se riscontri che molti o tutti i segnali di allarme si stanno manifestando nel tuo ambiente familiare, puoi rivolgerti a servizi territoriali creati ad hoc per aiutare chi si trova in difficoltà :
- Psicologo privato o consultorio familiare
- Centro di Salute Mentale (CSM) del tuo territorio
- Servizi Sociali comunali
- Pronto soccorso o 112 in caso di emergenza
Chiedere aiuto non è un fallimento, ma il primo gesto di protezione per te e per tuo figlio.
Hai paura che tuo figlio possa diventare violento ma non sai a chi rivolgerti?
Un confronto con un professionista può offrire nuovi strumenti per affrontare la situazione.
Come prevenire la violenza in famiglia e rafforzare il legame madre-figlio?
Come insegnare a un figlio a gestire la rabbia fin dall’infanzia?
La gestione della rabbia si costruisce nel tempo. Tre suggerimenti utili:
Valida le emozioni:
rispondere a un comportamento violento con frasi come "Capisco che sei arrabbiato" permette a tuo figlio di sentirsi prima di tutto compreso e quindi più predisposto a cercare aiuto o ascolto.
Insegna strategie di calma:
anche se tuo figlio è ormai adolescente o adulto, puoi suggerirgli una tecnica semplice per calmarsi e tornare al presente.
Si tratta dello STOP:
- S (stop) ovvero fermarsi un momento da qualunque attività stia svolgendo e portare l'attenzione al corpo
- T (take a breath) ovvero fare un profondo respiro ad occhi chiusi
- O (observe) ovvero riaprire gli occhi e osservare ciò che ci circonda
- P (proceed) ovvero riprendi a svolgere l'azione interrotta
Parla della rabbia:
molti bambini e adolescenti pensano che essere arrabbiati sia negativo e quindi non credono di potersi concedere questo sentimento. Iniziare sin da subito a normalizzare la rabbia come emozione e fornire i primi strumenti per esprimerla senza danneggiare gli altri, è un passo importante per crescere un bambino, e poi adulto, in grado di riconoscere questo sentimento e saperlo gestire.
Non è mai troppo tardi per iniziare a educare alle emozioni.
Quali strategie migliorano la comunicazione tra madre e figlio?
Tre strumenti fondamentali:
- Ascolto attivo: quando tuo figlio vuole parlarti cerca di ritagliarti un momento dedicato solo a lui invece di continuare a svolgere le attività quotidiane sentendo ciò che ti dice senza ascoltarlo realmente. Guardandolo negli occhi potrai aiutare te stessa a concentrarti su ciò che ti sta dicendo e tuo figlio a sentirsi veramente ascoltato.
- Comunicazione empatica: risposte a una discussione come"Mi fa male quando mi parli così, ma voglio capire cosa provi", permettono di spostare l'attenzione del gesto o della parola irrispettosa da te stesso come genitore vittima a tuo figlio come responsabile del comportamento sbagliato; tuttavia l'apertura riguardo la possibilità parlare e chiarire, è il segno di una tua chiara volontà di comprendere cosa prova tuo figlio e se possibile aiutarlo a stare meglio.
- Evita il "tu" accusatorio: meglio dire "Io mi sento..." invece di "Tu sei sempre...". Questa strategia di comunicazione efficace rientra tra i suggerimenti di ascolto attivo ma anche empatico e pone subito al centro della discussione i sentimenti e le emozioni anziché le recriminazione e le accuse.
Anche nei momenti di tensione, comunicare in modo chiaro può disinnescare molti conflitti.
Come gestire l’ansia e la paura di essere aggredita dal proprio figlio?
Come calmare l’ansia e i pensieri negativi legati alla sicurezza in famiglia?
La paura può generare pensieri catastrofici. Ecco come contenerli e rielaborarli:
- Scrivi quello che provi: tenere un diario o anche scrivere solo una lettera nei momenti no riduce l’ansia. Riprenderla a distanza di qualche settimana in un momento di calma e riflessione permette di prendere atto delle reazioni avute e rielaborarle in modo costruttivo al fine di riconoscere in futuro i segnali di ansia che stanno per manifestarsi
- Pratica la respirazione diaframmatica: spostare la respirazione dal torace al diaframma consente di passare da una respirazione superficiale a una profonda che permette di ossigenare tutti i tessuti e quindi migliorare la condizione fisica di tensione e quella psicologica di iperattivazione e ansia
- Parla con una persona fidata o uno specialista che sia in grado di spiegarti i motivi di questi pensieri e ridimensionare l'ansia correlata
L'ansia è una reazione normale a pensieri negativi e sensazioni di insicurezza tuttavia è necessario riconoscere quando questi sono motivati da segnali chiari e quando invece sono frutto di una percezione della realtà sovrastimata: rivolgerti a qualcuno che sappia ascoltarti e conosca queste dinamiche è la chiave per risolvere queste reazioni ansiose.
Quando una madre dovrebbe chiedere aiuto psicologico per se stessa?
Senti che l'ansia che provi interferisce con le tue attività quotidiane?
Per gran parte della giornata i tuoi pensieri sono rivolti alle preoccupazioni per i comportamenti di tuo figlio e la sensazione di insicurezza che ne deriva?
Senti che le persone con cui condividi questi pensieri non ti capiscono realmente e non sai come affrontare da sola questa sofferenza?
In questi casi, chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza. Uno psicologo può aiutarti a decifrare i motivi per cui provi ansia e i pensieri che sono alla base, cercare di accettare le preoccupazioni riguardanti la situazione che stai vivendo come strumento per non vivere sempre in conflitto con i tuoi pensieri e quindi vivere meglio, sapere che la persona a cui ti sei affidata conosce realmente ciò che stai provando e ha gli strumenti per aiutarti.
Domande frequenti delle madri che temono per la propria sicurezza
Un figlio con disturbo oppositivo o mentale può diventare violento?
Non necessariamente. Dipende dalla gravita del disturbo, dalla presenza di fattori di rischio e dalla possibilità di cura: questi tre fattori sono cruciali nel determinare la probabilità di comportamenti violenti. Un agito violento nasce sempre da un intreccio di fattori psicologici, sociali e culturali: nella prima categoria rientra non solo la personalità, che è un fattore innato, ma anche gli eventuali disturbi insorti nel corso dell'infanzia, adolescenza o età adulta. Tra i fattori sociali vi sono le esperienze vissute in famiglia, a scuola e nei contesti maggiormente frequentati. È un fattore su cui la famiglia gioca un ruolo importante e su cui si può sempre agire al fine di migliorarne le condizioni. Infine i fattori culturali riguardano, non solo l'appartenenza della famiglia a una cultura particolare o a una sottocultura i cui valori sono orientati positivamente o negativamente, ma anche alle scelte compiute dal figlio circa il contesto in cui vivere, influenzate dai genitori nei primi anni di vita, ma successivamente, dipendenti anche dalla volontà del figlio stesso.
Come proteggersi se si ha paura di essere aggredite in casa?
- Parla con uno specialista per valutare il rischio: un consultorio familiare o un assistente sociale possono aiutarti a comprendere meglio se c'è un reale pericolo e quindi agire di conseguenza
- Mantieni il dialogo aperto con tuo figlio, se possibile: questo permette a te di riconoscere eventuali ulteriori segnali di una violenza che sta per scoppiare, e a lui di non sentirsi ulteriormente isolato nel contesto domestico
- In caso di pericolo concreto, non esitare a contattare i servizi di emergenza o un centro antiviolenza
Quali azioni concrete posso fare oggi per stare meglio e tutelarmi?
- Riduci l’esposizione alla cronaca nera o non fermarti solo a ciò che di sensazionale dicono i media ma approfondisci per comprendere meglio il fenomeno
- Inizia un diario quotidiano per calmare la mente sovraffollata di pensieri e preoccupazioni
- Fissa un colloquio con uno psicologo
- Informati sui servizi attivi nel tuo territorio sia per aiutarti in caso di necessità sia per essere preparata ad aiutare tuo figlio in caso di necessità.
Anche se possono sembrare azioni irrisorie rispetto alla paura e all'insicurezza provate in questo momento, ricorda che sono i primi piccoli passi a fare la differenza e la costanza nel continuare a camminare a portare al cambiamento.
Bibliografia
- Bensley, L., Van Eenwyk, J., & Simmons, K. W. (2003). Childhood family violence history and women's risk for intimate partner violence and poor health. American Journal of Preventive Medicine.
- De Zulueta, F. (2006). The treatment of violence: A transgenerational approach. Journal of Family Therapy.
- Greitemeyer, T. (2011). Exposure to violent media increases aggression. Aggressive Behavior.
- Harris, G. T., & Rice, M. E. (2007). Risk appraisal and management of violent behavior. Psychiatric Services.
- Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder.
- Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psychopathology. Psychological Bulletin.
- Ponti G., Merzagora Betsos I. (2008). Compendio di criminologia. Raffaello Cortina Editore
- van der Kolk, B. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma.