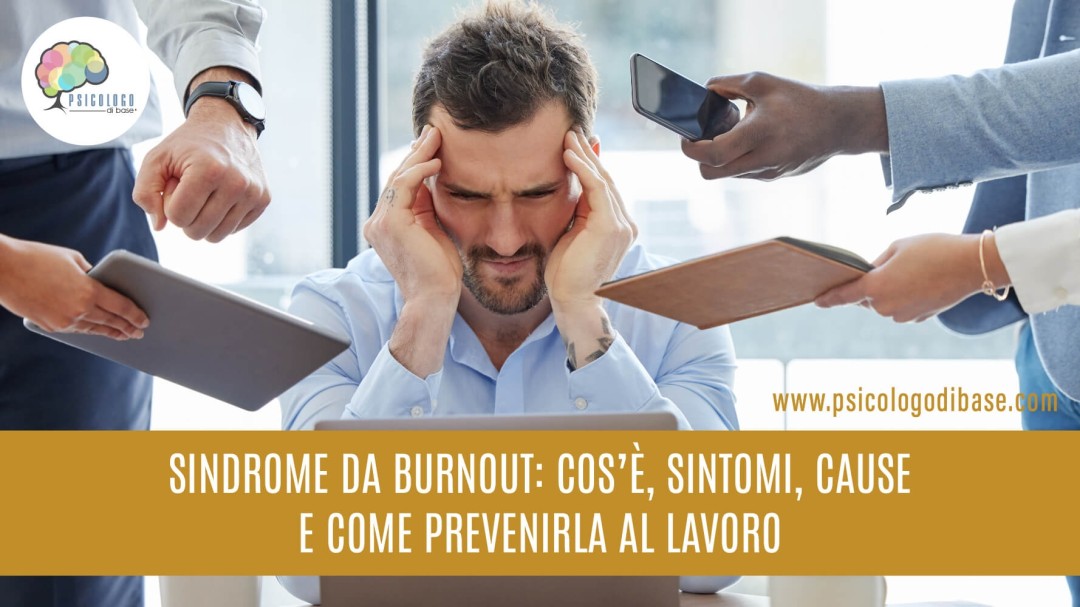- Cos’è il Burnout? Definizione e Contesto Lavorativo
- Che Cos’è il Burnout? Definizione e Sintomi Principali
- Cause del Burnout: Fattori Personali e Lavorativi
- I sintomi del burnout
- Come Prevenire il Burnout e Migliorare il Benessere Lavorativo
- Perché prevenire il burnout è fondamentale per il benessere lavorativo
Cos’è il Burnout? Definizione e Contesto Lavorativo
La sindrome da burnout è uno stato di esaurimento psicofisico causato dallo stress lavoro-correlato. Questo fenomeno, riconosciuto dall’OMS, colpisce sempre più lavoratori. Scopri sintomi, cause e come prevenirlo. Costituisce un importante ambito per la definizione e ridefinizione dell’identità individuale (il Sé) e dell’identità sociale: quello che siamo in rapporto al proprio gruppo di riferimento. Al tempo stesso sono molti i fattori che possono rendere l’attività lavorativa fonte di risposte di stress, sia dal punto di vista comportamentale che fisiopatologico (Sarchelli G., 2010). Lo stress, in termini generali, è stato definito come una risposta, ora come stimolo, ora come processo che risulta dall’interazione tra stimolo e risposta (Cooper, Dewe, 2004). Si tratta di un evento psico-somatico che si differenzia per la sua potenza e/o durata da una situazione normale intra individuale e viene scatenato da certe sollecitazioni esterne ed interne (stressors). I problemi infatti si verificano quando lo stress è troppo elevato o se la situazione stressante si prolunga eccessivamente nel tempo, con possibili conseguenze sia a livello fisico che psichico. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa.
Cos’è la sindrome da burnout? Una panoramica
È osservazione comune che non tutti reagiscono allo stesso modo nelle situazioni critiche. C’è chi tende più facilmente a scoraggiarsi e a temere il fallimento e chi invece, pur consapevole delle difficoltà, riesce a mantenere un impegno costante e proattivo senza farsi fermare quando le cose non vanno bene. È evidente che questi due stili descritti nascono da modi diversi di sentire e valutare le situazioni e portano a modi di agire differenti (Mannino L., 2021).
Nel nostro ordinamento lo stress lavoro-correlato è definito nell’Accordo europeo stipulato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 (recepito in data 9 giugno 2008 per via di Accordo Interconfederale), come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono adatti a corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro (Rosiello A., n.d). Lavorare ci pone delle sfide pratiche e relazionali che, se per certi versi percepiamo come stimolanti a livello personale e professionale, per altri possono trasformarsi in importanti fonti di stress. In quest’ultimo caso può diventare logorante affrontare le giornate lavorative, che si fanno così sempre più connotate da ansia, frustrazione, rabbia e preoccupazioni (Scaramagli, 2016). Dover affrontare una situazione difficile può infatti indurre una reazione di adattamento nel soggetto coinvolto, e quest’ultima può cristallizzarsi in una vera e propria sindrome, chiamata “Burnout Syndrome”, o “Sindrome da esaurimento da lavoro” (GVM, 2021). Il burnout non si manifesta all’improvviso. La sua natura è molto più insidiosa, si fa strada in noi nel tempo, un po’ alla volta, rendendolo così molto più difficile da riconoscere (Bourg Carter, 2013). Secondo un sondaggio del 2022 dell’American Psychological Association, oltre il 50% dei lavoratori ha riferito di soffrire attualmente di burnout. Esaurimento e burnout sono oggi ai massimi storici (APA, 2022).
Nel presente articolo, come evidenzia già il titolo, si parlerà del fenomeno burnout e delle strategie di prevenzione e promozione del benessere. Partendo dalla sua definizione, storia ed evoluzione si arriverà ad illustrare quali sono le condizioni predisponenti il burnout. Verrà chiarito come alcuni aspetti possono facilitare o ostacolare la messa in campo delle risorse personali che portano alla sintomatologia, di come sia possibile ed importante fermarsi e riflettere sul proprio modo di affrontare la questione lavorativa, anche a livello emotivo evidenziando l’importanza della prevenzione e supporto. Per approfondire la definizione ufficiale del burnout, visita il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Ti senti sopraffatto o esausto al lavoro?
Scopri come riconoscere i segnali del burnout prima che diventi un problema cronico. Informarsi è il primo passo per proteggere il tuo benessere.
Che Cos’è il Burnout? Definizione e Sintomi Principali
Il termine burnout è un termine di origine anglosassone che letteralmente significa esaurimento, crollo o surriscaldamento e che dà chiaramente l’idea di ciò che contraddistingue chi vive tale condizione. Con burnout si fa quindi riferimento allo stress sperimentato nel contesto lavorativo e/o derivante da esso, che determina un malessere psicofisico ed emotivo, accompagnato da vissuti di demotivazione, di delusione e di disinteresse con concrete conseguenze per l’individuo, non solo sul piano lavorativo, ma anche personale e sociale (Scaramagli, 2016). Il Dizionario di Medicina (2010) definisce burnout come uno “stato patologico (dall’inglese «bruciare completamente») che si verifica in individui che svolgono tutte le professioni, soprattutto quelle di aiuto. Ne sono interessati medici, poliziotti, infermieri, psicologi, ecc. Il burnout compare in figure professionali che devono sostenere in modo adeguato il proprio stress psicoemotivo e quello della persona assistita”.
L’undicesima revisione dell’International Classification of Diseases (ICD-11), approvata in data 25.05.2019 e in vigore dal 01.01.2022, descrive il burnout come un fenomeno occupazionale a sé stante, distinto sia dalle malattie professionali derivanti dai tradizionali fattori di rischio occupazionali che dai problemi legati a condizioni lavorative ricomprese nel rischio psicosociale (Di Prinzio R.R., Quintavalle G., Magnavita N,2019, pag. 46-54). È una condizione di disadattamento lavorativo, sancita a tutela del lavoratore in modo organico dal D.Lgs 81/2008. È altresì una sindrome riconosciuta come “fenomeno occupazionale” dall’OMS nel maggio del 2019 ma non ancora come una condizione medica (OMS, 2019). Infatti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non si tratta di una malattia, ma di una condizione medica di disagio lavorativo, “uno stato di stress cronico lavoro-correlato caratterizzato dalla sensazione di completo esaurimento delle proprie energie fisiche e mentali”.
Definizione ufficiale del burnout secondo l’OMS
Secondo un approccio specificatamente psicologico (Maslach, 2016), il burnout viene definito come un processo nel quale lo stress si trasforma in un meccanismo di difesa e una strategia di risposta alla tensione, con conseguenti comportamenti di distacco emozionale, difficoltà di adattamento ai cambiamenti e nell’affrontare le conseguenze che l’evento stressante comporta, con sensazioni di maggiore vulnerabilità e peggioramento della qualità della vita, anche dal punto di vista sociale e relazionale.
Le differenze tra stress e burnout
Valerio Salvarani, nel suo articolo sul web, ci aiuta a capire le radici del fenomeno evidenziando come la prima apparizione del termine burnout avviene nel 1930 nel gergo sportivo per indicare l’incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, di ottenere ulteriori risultati. Negli anni ’60 il termine veniva utilizzato per descrivere la condizione di chi abusa di stupefacenti e si sente bruciato dal loro uso, trovandosi senza risorse, energie e motivazioni. Dagli anni ’70 inizia a consolidarsi l’idea di burnout come una forma particolare di stress lavorativo specifico delle “helping profession”. Nel 1974, per la prima volta, il termine viene utilizzato in ambito socio-sanitario da Freudenberger e viene definito come “il fallire, l’esaurirsi a causa di un’eccessiva richiesta di energia e risorse”. Successivamente, nel 1976, il concetto viene ripreso da Maslach che utilizza il termine per identificare una sindrome i cui sintomi evidenziano l’insorgere di una patologia a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione personale. Infatti, rispetto alla ipotesi iniziale, che vedeva la sindrome come strettamente connessa alla relazione d’aiuto, gli studi successivi sembrano supportare maggiormente l’ipotesi che alcune condizioni lavorative, quali carico di lavoro, pressione temporale, scarsità di risorse, basso supporto sociale, mancanza di informazioni e feedback, bassa partecipazione ai processi decisionali e basso controllo, siano fortemente correlate al burnout (Leiter M.P., Robichaud L.,1997). Esse danno una forma di erosione del naturale impegno e coinvolgimento sul lavoro: ciò che inizia come significativo e sfidante diventa spiacevole, inappagante e senza significato.
Cause del Burnout: Fattori Personali e Lavorativi
Il burnout si manifesta principalmente in professionisti di settori orientati al servizio di aiuto che affrontano livelli elevati e prolungati di stress. Questa sindrome deriva dallo stress che si sviluppa attraverso la relazione sociale tra un assistente e un destinatario dell’aiuto (Awa et al., 2010). Tutti coloro che svolgono una professione sono potenzialmente a rischio burnout anche se quelli che corrono i rischi maggiori sono quelli che lavorano nelle cosiddette “professioni d’aiuto”, quindi medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali etc (Romani M., Ashkar, K., 2015). Anche altri professionisti, come forze dell’ordine, guardie carcerarie e pompieri, spesso a contatto con altre persone o impegnate a gestire emergenze, possono andare facilmente incontro al burnout (Maria Luigia, 2022). Per molti anni, il burnout è stato riconosciuto come un rischio professionale per varie professioni orientate alla persona, come i servizi umani, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Le relazioni terapeutiche o di servizio che tali fornitori sviluppano con i destinatari richiedono un livello continuo e intenso di contatto personale ed emotivo. Sebbene tali relazioni possano essere gratificanti e coinvolgenti, possono anche essere piuttosto stressanti (Maslach C., Leiter M.P., 2016). Secondo molti ricercatori infatti, l’essere costantemente a contatto con i bisogni e le necessità dell’utenza è un fattore stressante che, se non adeguatamente contrastato, può favorire l’insorgere del burnout (Chandawarkar A., Chaparro, J. D., 2021).
Il burnout è una sindrome ad origine multifattoriale e diverse sono quindi le cause che possono scatenarla. In genere a scatenarla è un mix di fattori personali e del contesto organizzativo. L’ambiente di lavoro ricopre un ruolo importante. Numerose sono le aree della vita organizzativa in cui le istanze soggettive, non trovando adeguati riscontri oggettivi, contribuiscono ad accentuare il rischio di burnout (Cattelani R., 2003, 239-241).
Vuoi imparare a prevenire il burnout e migliorare la qualità della tua vita lavorativa?
Esplora le strategie più efficaci per mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Piccole azioni possono fare una grande differenza.
I fattori di rischio lavorativi per il burnout
Particolare attenzione viene posta sul grado di accordo (match) o disaccordo (mismatch) tra la persona e sei aspetti dell’ambiente di lavoro (Avallone, 2013, pag. 662):
- Carico di lavoro: generato da una richiesta lavorativa elevata associata ad una difficoltà di recupero delle energie;
- Il controllo: nel senso di un controllo insufficiente sulle risorse necessarie al lavoro, oppure di un’autorità insufficiente a svolgere il lavoro nella maniera ritenuta più valida ed efficace;
- Il riconoscimento: il cui aspetto è legato a quanto le persone vedono ignorato e non apprezzato dagli altri il proprio lavoro;
- Il supporto: quando le persone sentono di aver perso la connessione con gli altri al lavoro e sono presenti conflitti cronici ed irrisolti;
- L’equità: legata al senso di reciproco rispetto, alla distribuzione del carico di lavoro o della retribuzione, o quando avanzamenti e promozioni risultano inappropriati;
- I valori: in riferimento a quando esiste un conflitto tra valori della persona e quelli dell’organizzazione.
Secondo i sostenitori dell’approccio clinico-analitico di Freudenberger, il rischio di burnout sarebbe direttamente connesso ad alcune caratteristiche personologiche relative alle capacità ed alla conseguente vulnerabilità psicologica del soggetto che svolge l’attività lavorativa in un ambiente stressante (Cattelani R., 2003, pag. 236). Infatti, sono state correlate significativamente al rischio di burnout alcune caratteristiche personologiche.
Fattori personali che aumentano il rischio di burnout
Tra queste, una tendenza al perfezionismo, una visione pessimistica di sé stessi e del mondo, il bisogno di mantenere il controllo e il porsi obiettivi e traguardi professionali troppo elevati e irrealistici (Boutou, 2019). Alcuni studi hanno evidenziato, inoltre, che anche variabili demografiche come l’età, il genere, lo status, il livello di scolarizzazione, l’attività di studio in corso o la qualifica professionale, possono essere fattori influenti sul burnout (Cattelani R., 2003, pag. 237-239). Diviene così sempre più chiaro che il burnout è la conseguenza di un’interazione tra la persona e il proprio contesto lavorativo.
I sintomi del burnout
I sintomi associati alla sindrome sono complessi e posso riguardare tre ambiti diversi (Scaramagli L., 2016; GVM, 2021):
I sintomi emotivi e cognitivi del burnout
Livello Cognitivo/Emotivo: distacco emotivo, trascuratezza degli affetti e delle relazioni sociali, importanza eccessiva data al lavoro, demotivazione al lavoro, difficoltà di concentrazione, irritabilità e senso di colpa. Il soggetto sperimenta una vera e propria disaffezione al proprio lavoro che porta a una caduta dell’autostima, a un crollo delle energie psichiche e motivazionali ed episodi di comportamento autodistruttivo. I principali sintomi psichici sono: senso di fallimento o di scarsa autostima, sentirsi senza speranza, intrappolato o sconfitto, sensazioni di distacco dal proprio lavoro, perdita di motivazione, ridotta soddisfazione e senso di realizzazione, stato di costante tensione e irritabilità, cinismo;
I comportamenti a rischio legati al burnout
Livello Comportamentale: aggressività, abuso di alcool e sostanze, mancanza di iniziativa, assenteismo. Il burnout può stimolare comportamenti che costituiscono un rischio per la salute come eventi autodistruttivi (alcolismo, tabagismo, uso di stupefacenti), comportamenti eterodistruttivi (atti violenti o crudeli verso gli utenti/pazienti) e/o che testimoniano un forte disimpegno sul lavoro, di rinuncia a prendersi delle responsabilità, procrastinazione e ridotta produttività;
I sintomi fisici del burnout
Livello Fisico: emicrania, sintomi respiratori, insonnia, inappetenza, disturbi intestinali, senso di debolezza. La sindrome provoca, o più spesso aggrava, alcuni disturbi di tipo psicosomatico, come sentirsi stanco o svotato per la maggior parte del tempo, avere basse difese immunitarie che causano malattie frequenti, lamentare frequenti mal di testa o dolori muscolari, manifestare cambiamenti nell’appetito e difficoltà nel sonno.
Il burnout nasce come sistematizzazione teorica di una sindrome soggettiva che rappresenta una conseguenza a stressor cronici di tipo emozionale e interpersonale presenti sul lavoro è, dunque, una risposta prolungata allo stress cronico da lavoro e si articola nei seguenti tre aspetti (Avallone, 2013, pag. 663):
- esaurimento emotivo: rappresenta la dimensione di base dello stress individuale. È caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo e da un eccessivo utilizzo delle risorse affettive;
- la depersonalizzazione (successivamente sostituita dal termine cinismo): rappresenta la componente interpersonale della sindrome, per il suo aspetto di distacco e distanziamento dalle persone prima (depersonalizzazione) e dal lavoro più in generale poi (cinismo);
- il senso di inefficacia personale: di inadeguatezza e di incapacità, che rappresenta la componente di autovalutazione del burnout.
Sulla base delle osservazioni di Cary Cherniss, ricercatore americano che ha approfondito la questione inerente alla definizione di burnout, è possibile delineare la configurazione sintomatologica ricorrente nella sindrome di burnout (Cattelani, 2003, pag. 234):
- resistenza a recarsi al lavoro quotidiano;
- sensazione di fallimento;
- sentimenti di rabbia e risentimento, scoraggiamento e indifferenza;
- netta riduzione dell’autostima;
- isolamento e ritiro sociale;
- senso di stanchezza cronica;
- sensazione che il tempo non passi mai;
- marcata sensazione di affaticamento dopo il lavoro;
- perdita di sentimenti positivi verso gli utenti;
- tendenza a rimandare contatti, telefonate, visite;
- concezioni stereotipate circa il comportamento degli utenti;
- incapacità di concentrarsi o di ascoltare l’altro;
- sensazione di immobilismo;
- cinismo verso gli utenti e atteggiamento colpevolizzante nei loro confronti nel caso falliscono gli obiettivi;
- tendenza all’applicazione rigorosa e acritica delle procedure;
- problemi del ritmo sonno-veglia;
- spiccata tendenza all’evitamento delle discussioni con i colleghi;
- frequenti rimuginazioni;
- aumento dell’approvazione verso la somministrazione, anche indiscriminata, di sostanze psicoattive per il controllo del comportamento degli utenti;
- frequenti disturbi di natura psico-organica (somatizzazioni);
- rigidità di pensiero e resistenza a qualsiasi cambiamento;
- sospettosità e ideazioni persecutorie, con proiezione sugli altri di propri sentimenti ed emozioni, incremento di conflitti e contrasti in famiglia;
Il burnout sta influenzando la tua vita quotidiana?
Frase di accompagno: Non lasciare che lo stress lavorativo condizioni la tua serenità. Contatta uno psicologo per un consulto mirato.
Come Prevenire il Burnout e Migliorare il Benessere Lavorativo
La ricerca scientifica enfatizza le gravi conseguenze del burnout sul luogo di lavoro, sottolineando l’importanza di interventi preventivi e di un’identificazione precoce. Affrontare il burnout è una sfida collettiva che richiede l’impegno di individui, datori di lavoro e politiche aziendali a sostegno della salute mentale. Per affrontare il burnout è essenziale agire in modo proattivo. Il “Mental Health Atlas 2020” dell’OMS (2021) sottolinea l’importanza delle tecniche di gestione dello stress, come esercizi di respirazione e metodi di risoluzione dei problemi. Inoltre, riconosce il ruolo cruciale dei programmi di prevenzione e promozione della salute mentale legati al lavoro. Questi programmi, coordinati tra settori sanitari, del lavoro e dell’impiego, mirano a contrastare lo stress legato al lavoro e a promuovere la salute mentale sul posto di lavoro (Ocera A., 2014).
Strategie di prevenzione del burnout a livello individuale
Gli interventi di gestione e prevenzione dello stress possono avere una diversa natura (Holman et al., 2018):
- Prevenzione primaria: lo scopo di un intervento primario a livello individuale è prevenire che lo stress si verifichi in un dipendente. Un mezzo per raggiungere questo obiettivo è attraverso procedure di selezione e valutazione, scegliendo candidati dotati delle competenze e capacità necessarie per gestire le richieste del lavoro;
- Prevenzione secondaria: gli interventi a livello individuale di tipo secondario mirano a fornire ai dipendenti le competenze e le abilità necessarie per gestire lo stress e promuovere il benessere, oltre ad offrire opportunità ai dipendenti di partecipare ad attività finalizzate alla riduzione dello stress. Queste includono tecniche come il rilassamento, la meditazione, la terapia cognitivo-comportamentale, la mindfulness e programmi di attività fisica, così come altre tecniche tra le quali l’educazione e lo sviluppo delle competenze relazionali;
- Prevenzione terziaria: gli interventi a livello individuale di tipo terziario si concentrano su individui che stanno vivendo livelli elevati o cronici di stress che potrebbero compromettere la loro capacità di lavorare. Ad esempio, i programmi di assistenza ai dipendenti forniscono consulenze a coloro che stanno affrontando livelli elevati di stress o problemi di salute mentale, indipendentemente dal fatto che tali problematiche siano legate al lavoro o meno.
Prevenzione del burnout a livello organizzativo
I costi personali e organizzativi del burnout hanno portato a proposte per varie strategie di intervento. L'intervento può avvenire a livello individuale, di gruppo di lavoro o di un'intera organizzazione (Maslach C., Leiter M.P., 2016).
- Gli interventi di sostegno indirizzati alle singole persone si rivelano particolarmente indicati a livello preventivo, oppure in condizioni di burnout non conclamato, cioè nelle fasi prodromiche o nei casi di scompenso di lieve/moderata entità. Uno dei requisiti essenziali per la proponibilità di un intervento di sostegno individuale è lo sviluppo o la conservazione di un sufficiente livello di consapevolezza di sé (riconoscimento dei propri limiti e dei punti di forza) e di sufficienti capacità di riconoscimento e di analisi dei potenziali fattori di stress (Cattelani R., 2003, pag. 242). Le raccomandazioni più comuni includono (Maslach C., Goldberg J, 1998; Maria Luigia, 2022):
- modificare i modelli di lavoro (ad esempio, lavorare meno, fare più pause, evitare il lavoro straordinario, conciliare il lavoro con il resto della vita). Trovare equilibrio tra vita privata e vita professionale: una vita dedicata completamente al lavoro aumenta il rischio di burnout. Trovare altre fonti di soddisfazione (nelle relazioni interpersonali, in un hobby, nel volontariato etc.) aiuta a vivere più serenamente anche il lavoro;
- sviluppare abilità di coping (ad esempio, ristrutturazione cognitiva, risoluzione dei conflitti, gestione del tempo). Riposarsi: andare in ferie, svagarsi, dedicare il giusto tempo al riposo sono spesso antidoti importanti per il burnout;
- ottenere supporto sociale (sia dai colleghi che dalla famiglia). Migliorare le relazioni sul posto di lavoro, ovvero avere relazioni più positive con colleghi, superiori e sottoposti riduce il rischio di burnout e aiuta a gestirlo;
- utilizzare strategie di rilassamento;
- promuovere la buona salute e la forma fisica. Fare attività fisica: l’attività fisica regolare è un ottimo strumento di gestione dello stress;
- sviluppare una migliore comprensione di sé (attraverso varie tecniche autoanalitiche, consulenza o terapia).
- Il gruppo di lavoro è riconosciuto come indispensabile supporto all’attività socio-assistenziale e, dunque, l’equipe assume un’importanza fondamentale sul piano della motivazione e della stabilità psicologica dei singoli operatori (Cattelani R., 2003, pag. 243).
- Il gruppo in formazione, che assume l’aspetto di una vera e propria sete di informazioni finalizzate ad incrementare l’autostima , l’autodifesa, il benessere psicoemotivo in quanto il suo scopo è anche quello di aiutare gli operatori ad acquisire capacità sempre più efficienti nell’interazione con l’utente e la sua famiglia (strutture, storie, obiettivi, ideologie, consuetudini) diversi dal proprio e talvolta in conflitto, e facilitare cosi il compito di individuazione di efficaci modelli comportamentali e relazionali nell’attività di cura e assistenza (Cattelani R., 2003, pag. 244).
Perché prevenire il burnout è fondamentale per il benessere lavorativo
L’esperienza del burnout è stata al centro di molte ricerche negli ultimi decenni. Sono state sviluppate misure, così come vari modelli teorici. Studi di ricerca condotti in molti paesi hanno contribuito a una migliore comprensione delle cause e delle conseguenze di questa disforia professionalmente specifica (Maslach C., Leiter M.P., 2016). L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) è da sempre attento alle nuove domande di salute e sicurezza con cui gli operatori della prevenzione si trovano oggi a confrontarsi. Da questo punto di vista è evidente che in questi ultimi anni stanno aumentando sia i problemi riconducibili al disagio lavorativo, sia le patologie attribuibili ad una origine multifattoriale (Menduto T., 2008). Occuparsi di questa problematica vuol dire rivolgere l’attenzione al disagio psichico e al contesto in cui si sviluppa, cercando di identificare precocemente ogni condizione di disagio ed attuare una costante politica di attenta gestione delle risorse umane. Interventi precoci sull’individuo e sull’azienda possono quindi essere di beneficio per l’individuo, per l’azienda, per la società ed anche per la famiglia su cui inevitabilmente si ripercuotono le ansie e le sofferenze individuali. Il crescente problema dello stress e del burnout richiede una maggiore attenzione e consapevolezza nella gestione a partire dalla prevenzione. Il contesto lavorativo odierno è sempre più complesso, risulta quindi sempre più vantaggioso individuare le variabili personali coinvolte nelle varie fasi dell’esperienza di lavoro. Infatti, oggi più che mai, occorre fare affidamento sulle qualità e potenzialità di ciascuno, cercando di sviluppare le capacità resilienti laddove sono carenti (Mannino L., 2021).
Come affrontare il burnout con il supporto di un professionista
Quando la sintomatologia del burnout è significativa, tuttavia è opportuno rivolgersi ad un professionista competente in materia. L’aiuto professionale può infatti aiutare a comprendere meglio il problema e a sviluppare gli strumenti utili per affrontarlo.
BIBLIOGRAFIA
- Avallone F., (2013), Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Carocci editore, Roma.
- Awa, W., Plaumann, M., Walter, U. (2010). Burnout prevention: a review of intervention programs, Patient education and counseling, 78 2, 184-9.
- Bakker AB., Demerouti E., MC Euwema MC., (2005), Le risorse lavorative attenuano l’impatto delle richieste di lavoro sul burnout, Giornale di psicologia della salute sul lavoro 10(2):170-80 DOI: 10.1037/1076-8998.10.2.170, PubMed.
- Boutou, A., Pitsiou, G., Sourla, E., & Kioumis, I. (2019). Burnout syndrome among emergency medicine physicians: an update on its prevalence and risk factors. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 23(20), 9058–9065.
- https://doi.org/10.26355/EURREV_201910_19308.
- Bourg Carter, S. (2013), The Tell Tale Signs of Burnout … Do You Have Them?. Psychology Today.
- Cattelani R., (2003), Elementi di Psicologia clinica, Carocci Faber, Roma.
- Chandawarkar, A., Chaparro, J. D. (2021). Burnout in clinicians. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 51(11), 101104. https://doi.org/10.1016/J.CPPEDS.2021.101104.
- Cooper C.L., Dewe P.J., (2004), Stress: A Brief History, Blackweel Publishing, Oxford (UK).
- Dizionario di Medicina, (2010), Burn-out, sindrome da, in https://www.treccani.it/enciclopedia/sindrome-da-burn-out_%28Dizionario-di-Medicina %29/.
- D.Lgs 81/2008.
- D.Lgs. 81/2008: conferme e novità in tema di stress correlato al lavoro di P.Deitinger, C.Nardella, R.Bentivenga, M.Ghelli, B.Persechino, S.Iavicoli, in https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/stress-lavoro-correlato-e-burnout/ #:~:text=Frequente%20derivazione%20dello%20stress%20occupazionale,nelle %20professioni%20stressanti%20(ad%20es.
- GVM, (2021), Stress sul lavoro: la sindrome da Burnout, in https://www.gvmnet.it/press-news/news-dalle-strutture/stress-sul-lavoro-la-sindrome-daburnout.
- Holman, D., Johnson, S., O’Connor, E. (2018). Stress management interventions: Improving subjective psychological well-being in the workplace, in https://www.stateofmind.it/2024/02/burnout-prevenzione-trattamento/International Classification of Diseases (ICD-11).
- ISPESL – Dipartimento di Medicina del Lavoro. La rilevazione del rischio psicosociale: rassegna di metodologia e strumenti di misura di Christian Nardella, Patrizia Deitinger, Antonio Aiello, in https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/stress-lavoro-correlato-eburnout/#:~:text=Frequente%20derivazione%20dello%20stress%20occupazionale,nelle %20professioni%20stressanti%20(ad%20es.
- Leiter M.P., Robichaud L., (1997), Trasferimento di conoscenze personali e organizzative:
- implicazioni per l'impegno nella vita lavorativa, in https://www.researchgate.net.
- Mannino L., (2021), La ricerca del lavoro passa da se stessi, in https://www.stateofmind.it/2021/06/ricerca-lavoro/.
- Maria Luigia, (2022), La sindrome da burnout, in https://www.ospedalemarialuigia.it/psicologiaapplicata/la-sindrome-burnout/.
- Maslach C., Goldberg J. (1998), Prevenzione del burnout: nuove prospettive. App Prevent Psychol 1998; 7 :63-74.
- Maslach, C., Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 15(2), 103–111. https://doi.org/10.1002/WPS.20311.
- Menduto T., (2008), Ispel: un dossier sui rischi psicosociali, in https://www.puntosicuro.it/documentazione-C-63/ispesl-un-dossier-sui-rischi-psicosocialiAR-8501/.
- Morgese M., (2023), Burnout, in https://www.stateofmind.it/burnout/.
- Ocera A., (2014), Stress e burnout: dalla prevenzione all’intervento, in https://www.stateofmind.it/2024/02/burnout-prevenzione-trattamento/#:~:text=Secondo %20una%20ricerca%20condotta%20dall,lavorativo%20(OMS%2C%202019).
- OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
- Reparata Rosa Di Prinzio, Giuseppe Quintavalle e Nicola Magnavita, in Ambiente&Sicurezza sul lavoro, Epc srl. A. XXXV, n. 12 (2019), p. 46-54 in https://www.regione.emiliaromagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/sicurezza-nelle-costruzioni/riviste-specializzate/ 2019/il-burnout-e-un-fenomeno-occupazionale-la-conferma-dell2019oms.
- Romani, M., Ashkar, K. (2014). Burnout among physicians. The Libyan Journal of Medicine, 9(1), in https://doi.org/10.3402/LJM.V9.23556.
- Rosiello A., (n.d.), Stress lavoro correlato e burnout, in https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/stress-lavoro-correlato-e burnout/#:~:text=Frequente%20derivazione%20dello%20stress%20occupazionale,nelle %20professioni%20stressanti%20(ad%20es.
- Sarchelli G., Fraccaroli F., (2010), Introduzione alla psicologia del lavoro, Bologna, Il Mulino.
- Salvarani V., (n.d.), Burnout nelle professioni saniarie, strategie di prevenzione e promozione del benessere, in https://www.opilecco.it/files/repository/20/609868eb5762744110df1a1c23a8b850.pdf.
- Scaramagli, L. (2016), Burnout e Mindfulness: un punto d’incontro, in https://www.stateofmind.it/burnout/.