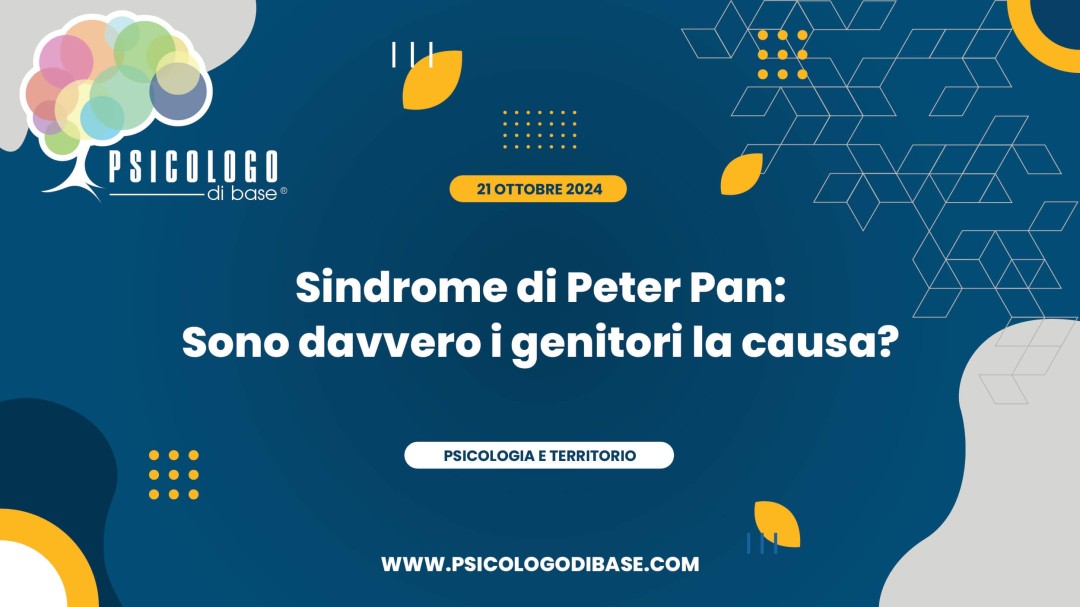La sindrome di Peter Pan è stata introdotta per la prima volta in ambito psicologico da Dan Kiley, uno psicologo statunitense, che nel suo libro “Sindrome di Peter Pan: uomini che non sono mai cresciuti” del 1983 descriveva per la prima volta una condizione psicologica, non riconosciuta come disturbo, di immaturità psicologica a fronte di uno sviluppo fisico nella norma.
Il termine neotenia psichica è stato adottato dal mondo antropologico per indicare uno stato di mantenimento e non alterazione di una condizione psichica, in questo caso proprio il livello di maturità emotiva, affettiva e sociale. Questo aspetto coinvolge l'intera personalità dell'uomo permeando ogni aspetto della sua vita, da quello relazionale a quello lavorativo ed economico.
Chi ha questa sindrome generalmente ha una personalità molto vivace ed estroversa, ama circondarsi di persone e sa come intrattenerle. Questo tratto è dovuto ad una generale immaturità emotiva in cui permane e che lo conduce a non prendersi responsabilità, a rifiutare di compiere delle scelte importanti o di effettuare quei passi necessari per abbandonare l'età adolescenziale e entrare in quella adulta.
Riuscire a mantenere la spensieratezza tipica dell'infanzia di per sé non costituisce il sintomo della sindrome di Peter Pan, purchè questi tratti siano limitati ad alcuni ambiti della vita e non riguardino invece l'intera esistenza della persona. Infatti gli “eterni bambini” tendono a distaccarsi anche dalla gestione finanziaria della loro vita, delegando alla famiglia o al partner le decisioni economiche importanti o semplicemente procrastinando la loro assunzione.
Dal punto di vista lavorativo sembrano non avere ancora preso una posizione sulle aspirazioni per il futuro: manca in loro la volontà di progredire o, molto spesso, anche solo di abbandonare i sogni d'infanzia in funzione della realizzazione di aspettative più realistiche.
Infine dal punto di vista relazionale chi ha la sindrome di Peter Pan, tende ad evitare il confronto e il conflitto poiché significherebbe prendere una posizione e quindi assumersi la responsabilità della decisione presa. Che sia in campo sentimentale o nei rapporti di amicizia, preferisce isolarsi e rompere qualunque legame invece di esprimersi e se necessario affrontare il conflitto.
La principale strategia adottata è quindi quella dell'evitamento ma anche altre forme di coping intervengono nel condurre la persona a non maturare: la rimozione è uno dei meccanismi più primitivi e diffusi che viene spesso adottato anche dagli eterni Peter Pan.
La razionalizzazione opera per giustificare i comportamenti adolescenziali di fronte alla richieste della società e del gruppo di pari in cui la persona è inserita.
La proiezione opera sia come forma di giustificazione del proprio modo di essere, proiettando sugli altri alcuni tratti propri e discutibili, sia come identificazione proiettiva laddove la persona proietta sull'altro le critiche ricevute e quindi gli aspetti più negativi del sé al fine di distanziarsene.
In questo caso non si può parlare di una vera e propria identificazione poiché chi ha questa sindrome generalmente non è consapevole di non aver raggiunto la piena maturità psicologica quindi difficilmente potrà identificarsi quando proietta sull'altro gli aspetti più negativi della sua personalità.
La sublimazione opera laddove emozioni e sentimenti trovano libero sfogo in attività che sono socialmente accettate: l'aspetto narcisistico di molti adulti con questa sindrome e la tendenza a circondarsi di amici e intrattenere molte relazioni, seppur tutte superficiali, possono essere considerate forme di sublimazione di una condizione emotiva irrisolta e che li conduce appunto ai comportamenti immaturi tipici di questa sindrome. Inoltre la tendenza di questi uomini è anche quella di sviluppare molteplici interessi senza tuttavia impegnarsi in alcuno in particolare.
Tutte queste strategie mirano a mantenere forte il senso di onnipotenza infantile di freudiana memoria che conduce il bambino a credere di poter raggiungere qualunque obiettivo prima di scontrarsi con la realtà della maturazione e con le nuove sfide che gli permettono di plasmare la sua personalità durante la tarda infanzia e la prima adolescenza. Queste persone non sembrano sopportare il senso di angoscia e di perdita tipica del passaggio all'età adulta ma soprattutto, altro tratto molto simile alla personalità narcisistica, la frustrazione del fallimento, conseguente alle nuove sfide che ci si trova ad affrontare con l'ingresso nella maturità.
Le prime teorie sulla causa della Sindrome di Peter Pan
Nel corso degli anni '80 e '90 in corrispondenza dell'ampio respiro che la definizione di Kiley della sindrome, aveva avuto in campo psicologico e sociologico, sono emerse le prime teorie volte a spiegare le possibili cause di questa sindrome.
Una prima possibile spiegazione è stata ricondotta allo stile di attaccamento che i bambini sviluppano nei primi anni di vita e che condurrebbe a sviluppare modalità relazionali diverse e variegate a seconda del rapporto reciproco tra genitori e figli soprattutto nella primissima infanzia.
Erikson aveva ipotizzato che sin dalla nascita ogni bambino sviluppa una forma di attaccamento con il caregiver cioè con la persona che provvede a lui in termini di bisogni primari e affettivi. Subito dopo la nascita l'attaccamento è un legame biologico dettato dall'esigenza di sopravvivere, tuttavia con l'evoluzione dei bisogni del bambino, anche il legame con chi si prende cura del bambino, non riguarda solo il soddisfacimento dei bisogni primari ma si sposta sul piano emotivo ed affettivo: il bambino ha bisogno di sviluppare fiducia nei confronti del genitore e di sintonizzarsi emotivamente con lui.
Uno stile di attaccamento evitante si manifesta quando il bambino o il genitore non riescono a esprimere le loro emozioni all'altro per paura di essere rifiutati o di non trovare quell'affinità emotiva considerata importante per l'evoluzione del loro legame. Questa forma di evitamento emotivo conduce a non sviluppare mai abbastanza fiducia per poter esplorare liberamente il mondo circostante con la conseguenza che l'autostima e la fiducia in sé necessaria per affrontare le sfide dell'età adulta non costituiranno parte del patrimonio emotivo della persona, sempre orientata ad una regressione anziché a un progredire costante.
La seconda teoria che definisce un ruolo primario dei genitori nello sviluppo della Sindrome di Peter Pan è della psicologa Susan Krauss Whitbourne che ha ipotizzato che l'incapacità di maturare di questi uomini derivi da un atteggiamento educativo iperprotettivo dei genitori i quali non hanno permesso ai loro figli di sperimentare sfide e fallimenti. I cosiddetti “genitori elicottero” si comportano in modo eccessivamente protettivo verso i figli, impedendo loro di avere le normali esperienze di un bambino e quindi ostacolando il regolare sviluppo della personalità: i bambini le cui scelte sono sempre fatte dai genitori, non sono in grado, una volta adolescenti e poi adulti, di orientarsi nella società, prendere decisioni, comprendere i loro obiettivi futuri e agire di conseguenza. Nella maggior parte dei casi è la paura di sbagliare a bloccare questi giovani ma anche l'assenza di autostima costituisce un importante freno: ancora una volta l'assenza di indipendenza e di spirito di iniziativa, condizione che i “genitori elicottero” tendono a favorire nei figli al fine di evitare loro dei fallimenti, portano a non sviluppare fiducia nelle proprie capacità e un senso di inefficacia pervasivo.
Una ricerca del 2007 dell'Università di Granada ha poi confermato che l'atteggiamento iperprotettivo dei genitori è una possibile causa della Sindrome di Peter Pan: “di solito colpisce le persone non autosufficienti che sono state iperprotette dalle loro famiglie e non hanno sviluppato le competenze necessarie per affrontare la vita” da cui deriva la tendenza di questi giovani a vedere “il mondo degli adulti come molto problematico e glorificano l'adolescenza, motivo per cui vogliono rimanere in quello stato di privilegio”.
Le relazioni di queste persone sono brevi e superficiali, non appena si prospetta un impegno maggiore, tendono a fuggire e ricercare nuove relazioni meno impegnative. La sindrome, speculare a quella di Peter Pan, che riguarda le donne è la Sindrome di Wendy: queste tendono a giustificare la tendenza a rifuggire dagli impegni di chi è affetto da Sindrome di Peter Pan, prendendo tutte le decisioni che il partner rifiuta e appoggiandolo in tutti i comportamenti infantili. Non è un caso che queste donne tendono a diventare delle madri iperprotettive, perpetrando uno schema di attaccamento che influirà sulla crescita sana dei figli.
Le teorie alternative sulle cause dell'insorgenza della Sindrome di Peter Pan
Erikson ha spiegato lo sviluppo dell'identità del bambino ipotizzando l'attraversamento di 8 fasi: ognuna di queste, per essere superata, deve passare per un periodo di crisi che consente alla persona di acquisire le caratteristiche dello stadio in cui si trova e quindi prepararsi allo stadio successivo caratterizzato da un livello di maturità sempre maggiore.
Il passaggio più complesso sembra essere quello dall'adolescenza, quinto stadio, alla giovinezza e poi all'età matura: in questa fase il ragazzo sperimenta diverse identità, anche variandole in base al contesto sociale o culturale in cui si trova. La confusione tipica di questo periodo è necessaria per poter poi trovare un'identità definitiva che condurrà la persona verso la maturità e la sperimentazione di questa identità nelle relazioni e nei vari contesti in cui vive.
Chi ha questa sindrome tende a non superare mai il quinto stadio preferendo rimanere in una condizione di incertezza identitaria e quindi di costante sperimentazione. In questa scelta un ruolo sempre più importante è ricoperto dall'ambiente che circonda la persona, non solo in termini di nucleo familiare di provenienza: l'allungamento dei tempi dell'istruzione, con la possibilità di specializzarsi in modo sempre più approfondito e quindi con un maggior dispendio di tempo, l'incertezza del mondo del lavoro che impedisce spesso di affermarsi in questo ambito della vita, alimentando la precarietà della visione del futuro e quindi i cambiamenti di mansioni frequenti e la complessità delle relazioni alimentate dal ruolo sempre più importante dei social network, che spesso promuovono una leggerezza nei rapporti amorosi ma anche amicali con conseguente minor impegno richiesto nel mantenere queste relazioni, sono tutti fattori che stanno avendo un ruolo sempre più cruciale nella crescita degli adolescenti e giovani uomini.
È stato Adler nel 1907 a introdurre il concetto di “inferiorità d'organo”, inizialmente considerata come quella sensazione di inferiorità derivata dall'imperfezione del bambino nato con malattie o disturbi specifici. Quel senso di inferiorità si trasferiva dal piano fisico a quello psicologico rendendo la persona incapace di sviluppare un senso di efficacia e autostima e quindi impedendogli anche di affrontare le sfide quotidiane proprio nella convinzione di non essere in grado di superarle.
Successivamente la teoria ha visto un'evoluzione: anche un evento apparentemente insignificante nell'infanzia della persona può provocare una ferita narcisistica al sé che influirà sul suo sviluppo nel corso di tutta la sua vita. Si tratta di un sentimento che può definirsi ontologico, non dettato da un solo fattore ma più in generale dalla durata, superiore rispetto alle altre specie animali, del periodo di infanzia in cui il bambino sperimenta impotenza e dipendenza e vive quindi in pieno la condizione di imperfezione e inferiorità. Nell'età adulta questa condizione porta l'individuo a sviluppare uno stile di vita che Adler chiama “fittizio” o “nevrotico”.
Dato che la condizione di inefficacia influenza il modo di affrontare qualunque esperienza anche nell'età adulta, la tendenza è quella di porsi degli obiettivi fittizi ovvero la ricerca di una compensazione da questo sentimento attraverso una costante sfida nei confronti degli altri al fine di risultare migliore. Si tratta di uno scopo fittizio poiché il confronto con gli altri non risulterà mai vincente portando quindi la persona a sviluppare un falso sé e a vivere sempre spronato dalla competizione.
Poiché, tuttavia, l'uomo è un essere sociale e in quanto tale necessità di sviluppare rapporti sociali, talvolta essenziali per la sua sopravvivenza, il bisogno di primeggiare giunge, in una personalità non ben sviluppata, a scontrarsi con il sentimento sociale.
La volontà di adattarsi all'ambiente in cui si è inseriti trova un ostacolo nella volontà di potenza e di compensare il senso di inferiorità portando coloro che non hanno appreso a far convivere pacificamente queste due opposte esigenze, a isolarsi o, al contrario, a sviluppare relazioni superficiali e fittizie finalizzate esclusivamente al benessere personale. Un esempio di queste personalità sono coloro che rientrano nella Sindrome di Peter Pan.
Infine un altro approccio che ha cercato di spiegare l'insorgere di questa sindrome è quello di James Marcia, il quale è partito sempre dalla suddivisione in stadi dello sviluppo dell'identità concentrandosi nella fase delicata dell'adolescenza.
In questo stadio infatti si hanno i maggiori cambiamenti fisici, psicologici ma anche sociali, emotivi e relazionali della vita di una persona e le modalità con cui questa evoluzione viene affrontata è cruciale per comprendere come possano formarsi personalità difficili e problemi relazioni.
Combinando le due dimensioni dell'impegno e dell'esplorazione, Marcia ha individuato possibili condizioni di sviluppo dell'adolescente:
- la diffusione cioè l'assenza di impegno ed esplorazione con conseguente vagare senza uno scopo e senza alcuna iniziativa nel contesto sociale in cui la persona è inserita
- la preclusione si manifesta quando c'è impegno ma non esplorazione cioè il ragazzo non ha sperimentato le diverse identità, acquisendone una in modo acritico, spesso si tratta di quella di uno dei genitori, fortemente influenzato da questi e dalla loro educazione, ma altrettanto spesso è lo stesso individuo che, non avendo la volontà di ricercare una sua identità unica, ne segue una in cui meglio si rispecchia. Ciò implica anche far propri valori e principi non personali e originali ma acquisiti da terzi
- la moratoria cioè quello stato di piena esplorazione senza alcun impegno: in questa condizione la persona sperimenta in modo continuo senza mai scegliere quell'identità che più lo rappresenta. Il prolungamento di questo stato ben oltre la fase adolescenziale caratterizza chi ha la Sindrome di Peter Pan, poiché esclude in toto l'impegno come fattore che caratterizza la sua identità, continuando a cambiare interessi, attività, relazioni proprio per evitare di prendere una posizione definitiva e la responsabilità di questa
- il risultato è la meta ideale a cui aspirare con la fine dell'adolescenza anche se attualmente è spesso raggiunta nella fase della prima giovinezza o dell'età adulta: dopo aver esplorato e sperimentato diverse identità, se ne predilige una e si prende l'impegno di mantenerla, giungendo al suo pieno sviluppo con le fasi successive della vita: un lavoro, una famiglia, relazioni stabili e durature.
Indipendentemente da quale sia la causa della Sindrome di Peter Pan, la consapevolezza che qualche aspetto della propria vita sia problematico, è sempre il primo passo per affrontare tutti gli altri.
Come già specificato, questa sindrome si manifesta in modo non consapevole nella persona, poiché questa tende a considerare “normali” le modalità relazionali adottate.
Un aiuto esterno che possa identificare i nodi della condizione della persona e riconoscere le debolezze diventa quindi l'unico modo per affrontare e superare questa sindrome: ecco perché è sempre consigliato rivolgersi a uno specialista della salute mentale, in un primo momento per acquisire maggiore chiarezza circa le difficoltà che si stanno attraversando e le possibili cause e poi per favorire la ricerca della migliore strategia per acquisire quelle competenze importanti per un sano sviluppo di un'identità equilibrata.
Bibliografia:
- Napoleone Patrizia, Il modello del giovane-bambino: la sindrome di Peter Pan, 2018 in Psiconline - Il modello del giovane-bambino: la sindrome di Peter Pan (psiconline.it)
- AA.VV. “ I genitori iperprotettivi possono portare i bambini a sviluppare la "sindrome di Peter Pan", 2007, in ScienceDaily - I genitori iperprotettivi possono portare i bambini a sviluppare la "sindrome di Peter Pan" | Scienza Quotidiana (sciencedaily.com)
- Penzo A., Scalini L., “Adler e la psicologia individuale”, 2007 in Psichepedia - Adler e la Psicologia Individuale (psichepedia.it)
- Arini D. P., “Fenomeno della Sindrome Di Peterpan: Crisi Di Auto-Identità Nella Formazione Dell'Intimità Nell'Uomo Adulto” , 2019, in Researchgate - (PDF) Fenomeno della Sindrome Di Peterpan: Crisi Di Auto-Identità Nella Formazione Dell'Intimazione Nell'Uomo Adulto (researchgate.net)
- AA. VV., “James Marcia. Teoria dello sviluppo dell'identità”, 2021 in Bend Information - 15.2: James Marcia - Teoria dello sviluppo dell'identità - Social Sci LibreTexts | bend (gobend2020.com)