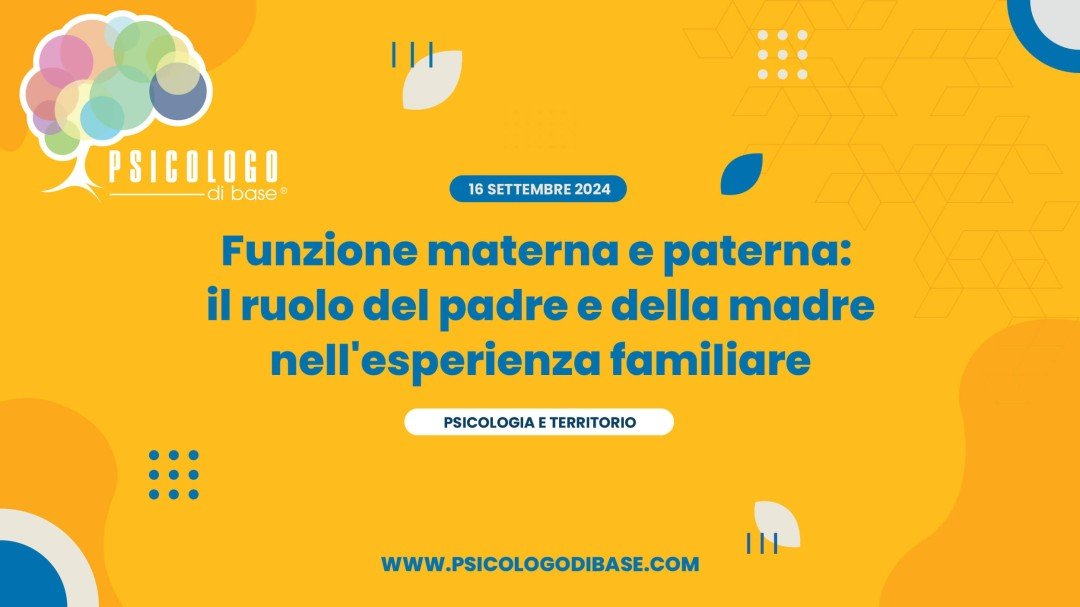Il ruolo materno e paterno, nell’esperienza familiare, ha due valenze differenti. Dal punto di vista simbolico, il ruolo materno è solitamente adibito alla cura, all’accoglimento, all’ascolto del figlio; quello paterno è, invece, un ruolo strategico all’interno della diade madre-figlio, in quanto appiana le ansie genitoriali e familiari, favorendo l'autonomia del figlio.
La funzione materna e paterna riguarda il maschile e femminile non inteso dal punto di vista dell’identità di genere, ma dal punto di vista simbolico, generico e umano. Non sono quindi funzioni ad esclusivo appannaggio del padre o della madre: tali ruoli si possono svolgere a prescindere dal proprio sesso di appartenenza.
La funzione materna è deputata all’accoglienza e all’accudimento, è la funzione di chi contiene, mantiene, si sintonizza e si prende cura dei bisogni psichici e fisici del bambino. Risponde ai bisogni di sicurezza del neonato, contiene la sua angoscia e l’accetta sia per ciò che è sia per ciò che fa. Questa funzione è “di norma” garantita dalla madre, ma è un funzionamento che ricopre anche il padre.
La funzione paterna è normativa e partecipativa. Detta, infatti, norme di comportamento, pone limiti, confini. Porta fuori, spinge il bambino ad emanciparsi, ad esplorare il mondo, a non rimanere nella dimensione materna, sicura, dipendente. La funzione paterna aiuta a comprendere le proprie paure e veicola le capacità per affrontarle. Anche in questo caso, “di norma” è una funzione che ricopre il padre, ma può essere assolta anche dalla madre.
È importante che i caregivers possano garantire al figlio entrambe le funzioni, affinché possa ricevere accudimento e sicurezza e nel contempo regole ed emancipazione.
La triade madre, padre e figlio
Nei primi anni di vita, tra madre e figlio sussiste una sana simbiosi che permette al bambino di sviluppare il sistema di attaccamento e la sua autostima. Il bambino, nel tempo, diventa capace di sviluppare un attaccamento multiplo con più figure di riferimento che costituiranno per lui un arricchimento. A questo proposito è fondamentale anche il ruolo del padre: sarà lui a sostenere la diade madre-bambino e la separazione del figlio dalla madre verso nuovi legami.
Il padre, secondo lo psicoanalista Bernard Golse, si caratterizza come il terzo tra madre e figlio e supporta quest’ultimo ad aprirsi al mondo esterno.
Il ruolo genitoriale
Essere genitori non è un compito semplice, così come è difficile essere figli. Il genitore non è responsabile soltanto del figlio, ma anche della società in cui vive; infatti, il figlio che ha “messo al mondo” sarà un futuro cittadino e ha quindi la responsabilità di educarlo al meglio, per il bene di tutta la società. Rispondere dei figli rispetto al mondo significa, per il genitore, avere la responsabilità e la consapevolezza del fatto che i figli non sono di proprietà dei genitori, ma sono “del mondo”.
Spesso, anche in chiave transgenerazionale, può capitare che, nei figli, si proiettino delle aspettative ereditate dalle famiglie d’origine dei caregivers. Sono i cosiddetti mandati familiari, ovvero un insieme di ruoli, compiti, aspettative che ogni componente della famiglia dovrebbe ricoprire e soddisfare.
La psicoanalista e saggista Laura Pigozzi, nel suo libro “Troppa famiglia fa male”, scrive: “E’ impossibile soddisfare un genitore, per struttura, non per incapacità, perché un figlio è sempre altro da ciò che era nelle fantasie di una madre o di un padre. Ogni genitore sarà sempre quindi un genitore “insoddisfatto”: tanto vale, per ogni figlio, prendere atto di questo limite universale e rivolgere le proprie energie altrove, in modo più costruttivo, inseguendo il desiderio che sostiene la propria vita”.
Il codice paterno e materno
Il codice paterno, dal punto di vista simbolico, aiuta il bambino nel processo di separazione dal grembo materno per uscire dalla fusione ed arrivare all’individuazione, all’affrancamento di sé. Il codice paterno ha il compito di favorire l’autonomia dei figli, il senso del limite, la socializzazione. Trasmette un senso di protezione, di sicurezza ma anche di entusiasmo, forza, ambizione, determinazione. Il codice paterno sposta lo sguardo dal passato al futuro, spinge il figlio ad andare altrove, ad uscire dal sistema familiare per conoscersi per davvero.
Il codice paterno è messo in atto sia dal padre sia dalla madre, poiché, come sosteneva Jung, ogni individuo possiede sia qualità maschili sia femminili. L'Anima rappresenta l'aspetto femminile presente nell'inconscio dell'uomo, mentre l'Animus rappresenta l'aspetto maschile nell'inconscio della donna.
Il codice educativo materno, presente anche nel padre, è quello preposto alla cura e attiene alla protezione del bambino, alla soddisfazione dei suoi bisogni e alla sua gratificazione. Nel primo anno di vita la prevalenza di questo codice è fondamentale poiché il neonato necessita di instaurare un rapporto simbiotico con la madre, improntato alla cura e all’accudimento, fondamentale per la sopravvivenza e l’acquisizione dello stile di attaccamento e dell’autostima.
Il distacco necessario
Antonio Quaglietta, psicologo e formatore, sostiene che la giusta distanza dalla famiglia d’origine consiste nel sapere cosa scegliere di tenere e cosa, invece, lasciar andare o trasformare rispetto a ciò che la famiglia insegna. Comprendere e conoscere le proprie origini significa poter decidere ciò che è utile portare dietro e cosa è bene tralasciare: è questo il compito evolutivo che appartiene ad ognuno di noi.
Concetti essenziali affinché si abbia uno svincolo sano dalla propria famiglia d’origine e ci possa essere una realizzazione completa e profonda del giovane adulto sono i seguenti. La differenziazione ha a che fare con la capacità di sapersi distinguere dalla massa familiare per poter trovare la propria strada e la propria realizzazione. Differenziarsi è un processo psichico necessario che fa parte del più grande processo di individuazione di una persona, ovvero quel processo – senza fine – per il quale si diventa ciò che si è. Una persona differenziata riesce a porre i giusti confini tra sé e gli altri in modo da non sentirsi invasa e in modo da non aver bisogno di attuare meccanismi di difesa quali evitamento, negazione o isolamento affinché la sua personalità sia rispettata. L’identificazione ha a che fare con il concetto di conoscenza di sé e capacità di accettazione di quel che si è. È la costruzione della propria identità di persona, del proprio carattere. È quel processo psicologico mediante il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e modellandosi su di essi. Grazie a questo processo possiamo divenire più intimi con noi stessi, in una profonda conoscenza di sé. L’individuazione è sinonimo di quel processo psichico unico e irripetibile di ogni individuo che consiste nell'approssimarsi dell'io al sé, cioè in una progressiva integrazione e unificazione delle ombre e dei complessi che formano la personalità dentro di sé. L’individuazione è un processo di integrazione delle componenti della personalità, il cui completamento può rappresentare la comprensione di Sé stessi. Scopo ultimo di tale processo è quindi la piena affermazione del Sé, che avviene mediante un vero e proprio viaggio di scoperta per capire chi siamo davvero. La definizione di sé ha a che fare col concetto di profonda conoscenza di sé ed è collegato al concetto di accettazione, di autostima, di amor proprio: “Io mi definisco e in quanto tale non temo di confondermi con gli altri, non temo di perdere me stesso nella relazione con l’altro, non temo di essere invaso”. Per imparare a definirsi ed amarsi, è necessario comprendere quanto incidano il proprio vissuto, le proprie credenze, convinzioni, abitudini, giudizi, preconcetti per poi accogliere sé stessi per ciò che si è. Amarsi è un concetto che si può apprendere. L’amore verso sé stessi è la chiave per potersi relazionare agli altri in maniera efficace. Amare sé stessi non è una forma di egoismo, bensì la possibilità di vivere pienamente la propria dimensione, senza dipendere dall’approvazione altrui.
Il genitore ideale è quello “affidatario”
Mariolina Ceriotti Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, nel suo libro “La famiglia imperfetta”, parla dell’importanza di accettare l’alterità del figlio e scrive “Il figlio ci viene affidato immeritatamente dalla vita perché lo accompagniamo per un pezzo di strada a diventare grande, la posizione più corretta dell’essere genitore è quella del genitore affidatario che si prende cura di una persona che ha sofferto, che ha problemi e a cui dà tutto ciò che ha. Significa dire che ci si guarda indietro, si riconosce di aver sbagliato e da lì si riparte facendo il meglio che si può”.
Lo psicoanalista Donald Winnicott parla del concetto di “Madre sufficientemente buona” riferendosi ad una madre e donna spontanea, autentica e vera che, con ansie e preoccupazioni, stanchezza, scoramenti e sensi di colpa, emerge come figura in grado di trasmettere sicurezza e amore. Accogliere, quindi, quelle che sono le proprie peculiarità, i propri errori, riconoscerne l’esistenza non per punirsi ma per poter crescere, migliorarsi.
A tal proposito esiste un insieme di servizi pubblici e di professionisti privati che posso aiutare madri e padri (anche futuri) a migliorare e crescere in questo importante e delicato ruolo: i consultori familiari, i corsi preparto, i corsi al supporto alla genitorialità tenuti da psicologi e pedagogisti, percorsi di parent-training e psicoeducazione per apprendere strumenti nuovi ed efficaci per la gestione dei propri figli e la comprensione dei bisogni dei bambini.
Bibliografia:
- Amana, Krishnananda, Trobe A., “A tu per tu con la paura. Vincere le proprie paure per imparare ad amare”, Milano, 2010
- Antonio Quaglietta, Psicologo, www.relazioniamoci.it
- Laura Pigozzi, Troppa famiglia fa male, 2020, Rizzoli
- Laura Pigozzi, Il plusmaterno, 2018, Poiesis
- Mariolina Ceriotti Migliarese, La famiglia imperfetta, 2019, Ares Mariolina Ceriotti Migliarese, Perfetti Imperfetti, 2022, Ares Mariolina Ceriotti Migliarese, La coppia imperfetta, 2023, Ares
- Stefania Andreoli, Papà, fatti sentire, Come liberare le proprie emozioni e diventare genitori migliori, 2018, Rizzoli