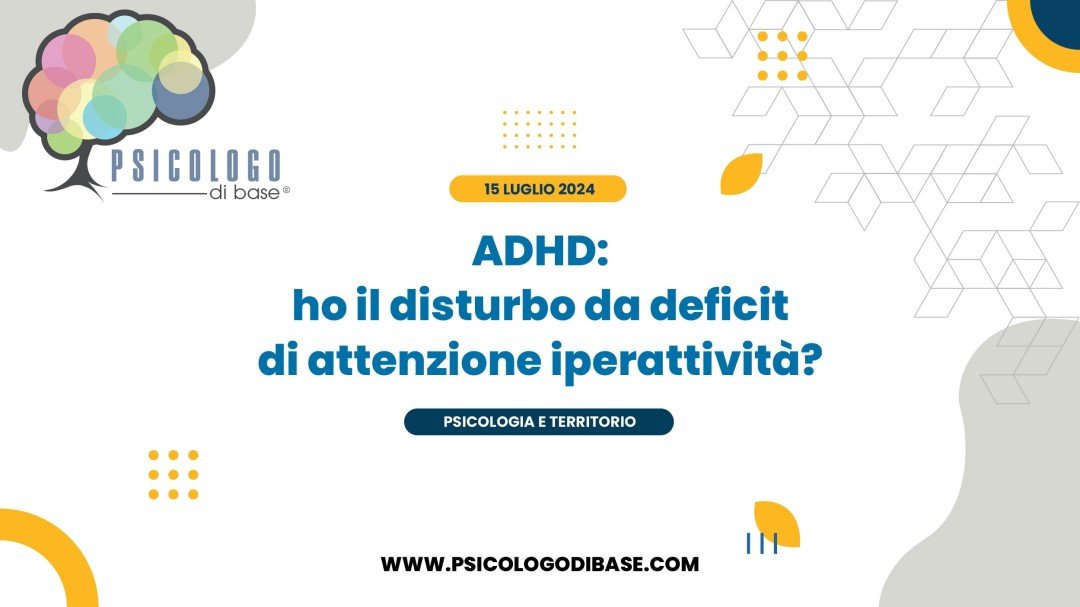Se ti stai chiedendo cosa significhi ADHD, vuoi saperne di più, o cercare di capire se tu o qualcuno che conosci possiate riconoscervi nei tratti di questa diagnosi sei capitato al posto giusto.
ADHD: definizione e sintomi
ADHD è un acronimo inglese che sta per Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tradotto in italiano nel Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività con cui si designa un disturbo del neurosviluppo che si manifesta in età evolutiva, cioè nell’infanzia, i cui sintomi cardine sono:
- disattenzione;
- iperattivà;
- impulsività.
Il disturbo, soprattutto se non riconosciuto e curato nell’infanzia, col procedere dell’età tende a coinvolgere pervasivamente sia il dominio neuropsicologico che psicosociale.
I sintomi che caratterizzano l’ADHD interessano aree di vita della persona così estese che tendono a strutturare un’organizzazione disfunzionale della personalità, simile alla bipolarità e al disturbo borderline. Per questo motivo è consigliabile intraprendere un percorso valutativo e diagnostico, così da ricevere precocemente l’accompagnamento terapeutico di cui si ha bisogno per migliorare la propria qualità di vita.
ADHD negli adulti
In questo articolo ti parlerò più dettagliatamente delle dinamiche funzionali, compensative e relazionali dell’adulto che ha ricevuto una diagnosi di ADHD, o che ne ha le caratteristiche.
Perché un articolo sull’ADHD in età adulta? Per tre motivi:
- l’ADHD è stata descritta nel DSM (Il manuale diagnostico dei disturbi mentali) solo nel 1968, quindi molti adulti di oggi possono non aver mai ricevuto una diagnosi ed essere affaticati dai metodi compensativi che hanno sviluppato da soli per adeguare la loro specificità alle richieste dell’ambiente;
- l’ADHD è un disturbo che interessa l’intero arco di vita;
- nell’adulto le tre principali aree sintomatologiche si esprimono diversamente rispetto al bambino.
Specificità dell’ADHD in età adulta
L’iperattività che il bambino esprime a livello di bisogni primariamente fisico, nell’adulto è più mentalizzata, e manifestata come il bisogno impellente di essere in movimento in quanto persona, esprimendosi spesso come bisogno di cambiare, di fare, per trovare risposta a un senso interiore di:
- irrequietezza ed agitazione che possono essere compensate da attività fisica frequente o diventare iperattività verbale (fino alla logorrea), o mentale (con pensieri intrusivi);
- incapacità a rilassarsi, per cui si possono ricercare strategie di auto medicamento che spesso si rivelano disfunzionali, come l’abuso di alcool, fumo, il consumo di sostanze o anche disregolazioni nelle condotte alimentari.
L’impulsività, derivante dalla difficoltà di considerare le conseguenze delle proprie azioni, si presenta in età adulta come una modalità disorganizzata di approcciarsi al mondo interno ed esterno, manifestandosi:
- internamente con l’intolleranza al sistema regolativo esterno fatto di regole e vincoli;
- esternamente con la difficoltà a rispettare impegni.
Dal punto di vista dei disturbi comportamentali questa percezione del mondo interno ed esterno può tradursi nelle seguenti condotte:
- shopping incontrollato;
- buttarsi nelle relazioni o sottrarsene improvvisamente;
Oltre a questi tre macro ambiti sintomatologici, quello che nell’adulto incide maggiormente sulla sua qualità di vita è:
- la difficoltà organizzativa;
- la disregolazione emotiva (Adler et al. 2017);
- l’instabilità dell’umore.
In particolare la disregolazione emotiva, e di conseguenza comportamentale, è il nucleo propulsore delle altre alterazioni che si possono alternare a seconda degli stimoli ambientali contingenti che acquisiscono una rilevanza specifica a seconda della biografia e a specifici eventi di vita (Navalesi, 2017).
Tutto questo ha un impatto importante sull’ambito lavorativo e anche, per quello che riguarda i giovani adulti, quello scolastico.
Le difficoltà attentive ostacolando il normale apprendimento, lo svolgimento del lavoro scolastico e l’organizzazione dello studio, portando i ragazzi ad abbandonare la scuola.
Analogamente sul lavoro l’incapacità nel rispettare gli orari, le regole e i vincoli organizzativi, insieme alla difficoltà di relazionarsi sia coi pari che con i superiori spinge verso il cambiamento piuttosto che verso il mantenimento di un medesimo ruolo.
A livello relazionale si possono avere risposte comportamentali inadeguate che generano un danno significativo sia al soggetto che alle persone con cui vive o entra in contatto secondo due possibili filoni di risposta:
- rinunciatario e sottrattivo;
- recriminatorio, polemico, oppositivo.
Tali filoni possono manifestarsi a livello comportamentale con:
- condotte antisociali;
- discontrollo dell’aggressività e delle condotte provocatorie ed oppositive.
ADHD in associazione con altri disturbi
La pervasità dell’ADHD fa sì che a questa diagnosi principale si possano associare altri disturbi che caratterizzano il funzionamento di vita delle persone. Secondo Katzman et al. 2017, l’ADHD può manifestarsi principalmente in associazione a:
- disturbi del sonno: nell’80% dei casi;
- disturbo d’ansia: nel 25-63% dei casi;
- abuso di sostanze e alterazioni della condotta alimentare: nel 25-66% dei casi.
ADHD e trattamento integrato
Gli adulti con una storia di vita caratterizzata dall’ADHD, nella maggioranza dei casi hanno sviluppato metodi più o meno funzionali per sfruttare positivamente i sintomi peculiari dell’ADHD che sono principalmente:
- l’apertura verso le novità e il coraggio di cambiare, che porta ad avere un buon livello di successo nel lavoro e nelle relazioni;
- l’abilità a catturare una molteplicità di stimoli che predispone alla creatività;
- l’iperfocalizzazione: uno stato intenso di concentrazione che annullando tutto il resto rende particolarmente efficaci nello svolgimento del compito ritenuto interessante.
Tuttavia questo si associa spesso alla fatica del convivere da molti anni coi sintomi e le limitazioni imposte dal disturbo.
È stato riscontrato (Arnold et al., 2015) che trattamenti integrati nella depressione sono associati al miglioramento delle condizioni di vita, in particolare nelle aree legate all’autostima e alla funzione sociale.
La psicoterapia
Le difficoltà comportamentali generate dall’ADHD finiscono per creare nell’individuo esperienze di vita fallimentari e un’immagine di sé negativa. Per questo, inizialmente, l’incontro con lo psicologo ha come scopo principiale quello di aiutare il paziente a migliorare la sua autostima, rielaborando le cause dei fallimenti passati legati all’effetto dell’ADHD non diagnosticato come:
- le delusioni derivanti dal porsi obiettivi mai raggiunti;
- le critiche dell’ambiente esterno che fa sentire inadeguati.
Nello spazio di ascolto e di dialogo con lo psicologo, si affronteranno i bisogni:
- psicologici;
- educativi;
- comportamentali;
- professionali
Questo percorso offrirà alla persona l’opportunità di esprimere le proprie potenzialità cimentandosi nello sperimentare nuove strategie di comportamento che migliorino la qualità di vita della persona che si è rivolta al terapeuta trovando risposta al suo disagio e alla sua sofferenza.
La farmacologia
Il percorso psicologico, lavorando sui bisogni del paziente è volto al migliorare la condizione esistenziale, e nel quadro di un più vasto intervento terapeutico multimodale, migliora la motivazione al percorso terapeutico per esempio riducendo la mancata aderenza al trattamento farmacologico (che può raggiungere anche il 64%, Mc Carthy 2014) che agendo sul sintomo allevia i disturbi caratteristici dell’ADHD.