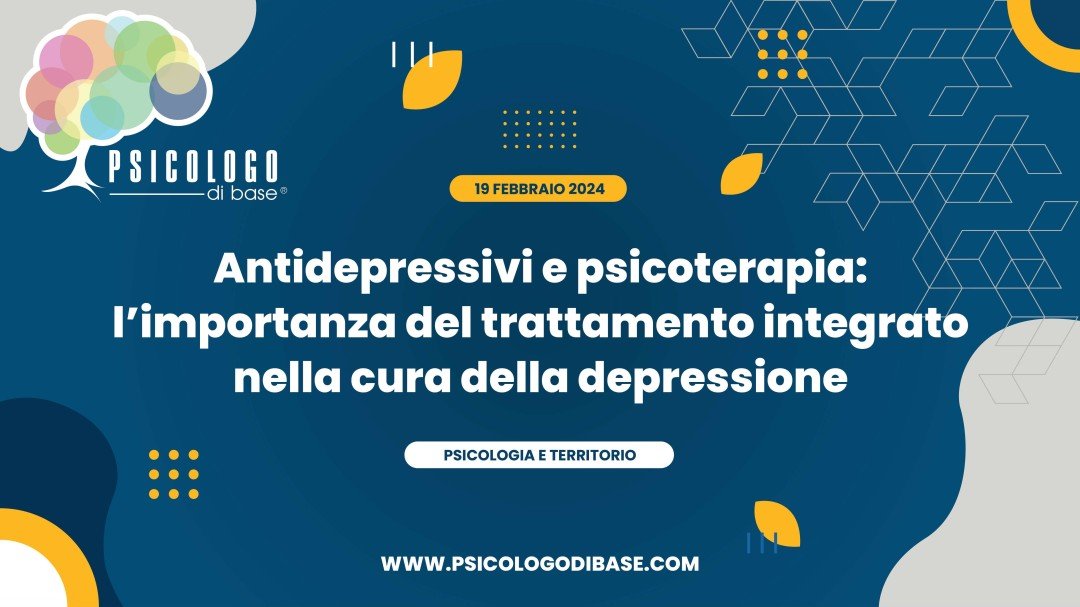Prozac, Cymbalta, Zoloft, Celexa. Questi sono i nomi di alcuni tra i più comuni psicofarmaci utilizzati per ridurre i sintomi depressivi in diverse psicopatologie, come il disturbo Depressivo Maggiore, il Disturbo ossessivo-compulsivo, il Disturbo post traumatico da stress e soprattutto nei disturbi dell’umore.
Ma qual è la loro effettiva utilità? Sono davvero in grado di curare la depressione?
Il disturbo depressivo maggiore
Ciò che viene comunemente identificata come depressione è un disturbo del tono dell’umore ed è definito da una serie di sintomi emotivi, affettivi, cognitivi e fisici che, quando individuati e diagnosticati, impediscono alla persona di vivere una vita in condizioni di benessere e quindi di salute.
Secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V-TR) i sintomi sono riferiti a diverse aree:
- Emotivi ed affettivi: Sono caratterizzanti della depressione dal momento che delineano l’umore depresso, ovvero un’affettività caratterizzata da estrema tristezza, malinconia, senso di vuoto, disperazione e perdita di speranza. La triade affettiva è rappresentata da anedonia (perdita di piacere), apatia (perdita d’interesse) ed astenia (perdita di energia).
- Cognitivi: Possono essere pensieri ricorrenti di autosvalutazione, senso di colpa, pessimismo, idee riferite al suicidio, difficoltà di concentrazione e nel prendere decisioni e nella progettualità futura.
- Fisici: Perdita di energia con conseguente rallentamento psicomotorio e sensazioni di affaticabilità, alterazioni dell’appetito che si esprime sia con la diminuzione che con l’aumento dello stesso, con conseguente alterazione del peso corporeo, alterazioni del sonno con insonnia iniziale; disturbi gastro-intestinali.
Lo sviluppo di un disturbo dell’umore è determinato da una serie di molteplici fattori e da eventi di vita che hanno effetti sulla salute, considerando la specifica vulnerabilità delle singole persone, la presenza della sintomatologia depressiva. Tra le ipotesi eziologiche più importanti ci sono:
- Ipotesi psicologica. L’elaborazione delle esperienze è ciò che permette alle persone di dare un significato soggettivo alla vita, interpretando sé stessi e gli altri. Alcuni eventi di vita stressanti, come trasferimenti, separazioni, perdite, malattie e fallimenti sociali vengono vissute dalle persone come avvenimenti irreparabili e totalizzanti. Il vissuto soggettivo di malinconia viene esteso dalla persona su tutta la propria vita, non riuscendo così a trovare la speranza per continuare a sperimentare gli accadimenti.
- Ipotesi neurobiologica. La sintomatologia depressiva sarebbe determinata da una serie di alterazione neuronali nella trasmissione celebrale. I neurotrasmettitori serotoninergici, noradrenergici e dopaminergici sono implicati nella regolazione del sonno, dell’appetito, delle capacità relazionali ed agentive della persona. Alterazioni nella regolazione di questi neurotrasmettitori darebbero vita alla sintomatologia depressiva. Questa ipotesi è abbastanza accreditata, soprattutto considerando il fatto che la cura farmacologica della depressione agisce proprio sulla regolazione di questi specifici neurotrasmettitori.
Secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato riscontrato un importante aumento delle diagnosi di depressione all’interno della popolazione mondiale, ed è preoccupante che essa sia stata prospettata come la prima causa di disabilità entro il 2030 (OMS, 2017). Per questo motivo negli ultimi decenni tutta la comunità scientifica sta sperimentando le migliori strategie per gestire e curare questo disturbo.
Il trattamento della depressione
Considerando la complessità del disturbo è necessario che esso venga trattato nella sua totalità, con l’obiettivo non solo di una remissione dei sintomi depressivi, ma soprattutto andando a potenziare le strategie utili alla persona per una migliore gestione sintomatica anche con un sostegno psicologico.
I sintomi depressivi possono infatti cronicizzarsi e per prevenire ciò è fondamentale che il loro trattamento sia personalizzato e si sviluppi all’interno di una rete di équipe multidisciplinare, secondo un’ottica integrata.
Gli antidepressivi
Gli antidepressivi rappresentano il trattamento farmacologico della sintomatologia. Essi agiscono sulle molecole di specifici neurotrasmettitori, ovvero la serotonina, la dopamina e la noradrenalina, in particolare sulla loro regolazione sulla loro presenza.
Come classificazione farmacologica possono essere raggruppati in cinque categorie:
- triciclici anti-Mao (inibitori delle mono-amino ossidasi);
- SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina);
- SNRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina);
- NARI (inibitori selettivi della ricaptazione della noradrenalina);
- antidepressivi atipici.
Ogni gruppo è specifico, e pur avendo effetti equivalenti dal punto di vista sintomatico, si differenziano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali. Il loro dosaggio e la loro prescrizione è quindi altamente personalizzata.
Senza dubbio dalla loro scoperta negli anni 50’, gli antidepressivi sono stati ampiamente utilizzati nel trattamento della depressione. Eppure attorno agli antidepressivi aleggia lo spettro di svariate fake news, che aumentano la probabilità di non aderenza al trattamento.
La più preoccupante risulta essere la falsa credenza che gli antidepressivi possano portare alla dipendenza. La nascita di questa idea potrebbe essere dovuta al fatto che, in effetti, l’interruzione immediata del farmaco antidepressivo provoca la sindrome da astinenza, con effetti collaterali come mal di stomaco, ansia, vertigini, convulsioni.
Eppure la condizione di dipendenza da antidepressivi si sviluppa esclusivamente quando il farmaco viene assunto non seguendo le indicazioni del medico psichiatra. Ciò nonostante c’è molta reticenza da parte delle persone ad assumere la cura farmacologica.
Potrebbe essere l’etimologia stessa della parola farmaco (dal greco antico φαρμακον), il cui significato varia da rimedio a veleno, ad evocare nelle persone l’idea sia di vita che di morte, e dunque portarle ad avvicinarsi o ad allontanarsi, a pensare al farmaco come pericoloso e protettivo, temuto e desiderato al tempo stesso (Bonner, et al. 2004).
Per aumentare dunque la possibilità che la persona aderisca alla terapia è necessario che lo psichiatra fornisca le informazioni sulla cura farmacologica il più chiaramente possibile.
Il trattamento integrato
Considerando la complessità della depressione, l’esclusiva cura sintomatica non garantisce la remissione del disturbo. Oltre alla cura farmacologica è fondamentale che la persona che soffra di questo disturbo possa essere inserita all’interno di un percorso integrato di trattamento, che preveda anche la psicoterapia.
Questo perché sono diverse le evidenze scientifiche che mostrano come, a seguito dell’interruzione della terapia farmacologica, sono frequenti le ricadute sintomatiche. Il trattamento più concreto per la depressione infatti non prevede solo la rimozione dei sintomi, ma soprattutto un percorso psicoterapico che permetta di modificare stili di pensiero e di vita strettamente connessi alla depressione.
Ad esempio è stato dimostrato che la psicoterapia è in grado di modificare le connessioni neuronali riferita alla riflessione sul sé, andando ad agire i pensieri autosvalutanti, tipici della depressione (Yoshimura S., et al. 2014) come ad esempio quando il pensionamento è causa di ansia e depressione.
Inoltre, considerando nello specifico l’aderenza alla terapia farmacologica, è stato riscontrato che essa aumenta quando la persona segue contemporaneamente una psicoterapia.
Pertanto l’intervento integrato rappresenta il trattamento elettivo per la depressione, sotto tutti i punti di vista.
Bibliografia
- OMS, (2017) Depression and other common mental disorders: global health estimates.
- American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2014
- Invernizzi G., Bressi C., (2012) Manuale di Psichiatria e psicologia clinica, The McGraw-Hill Companies, Milano.
- Yvonne D.B. Bonner, Maria Vittoria Andreoli, Maurizio Iemmi, Milvana Garamante, Raffaele Pellegrino, Franco Poziello, (2004) Farmaco buono o cattivo? Opinioni di un gruppo di familiari e di utenti in "RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA" .
- Yoshimura S, Okamoto Y, Onoda K, Matsunaga M, Okada G, Kunisato Y, Yoshino A, Ueda K, Suzuki S, Yamawaki S. (2014) Cognitive behavioral therapy for depression changes medial prefrontal and ventral anterior cingulate cortex activity associated with self-referential processing. Soc Cogn Affect Neurosci.