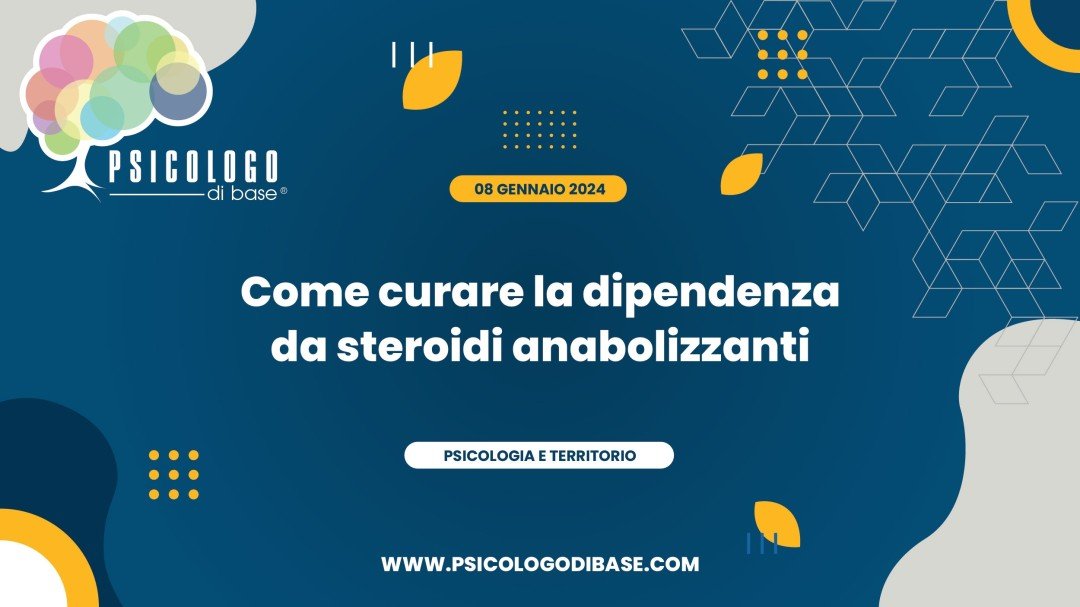Negli anni 50’, periodo in cui America e Russia si contendevano il primato come superpotenza mondiale, ha inizio la storia degli steroidi anabolizzanti.
Primeggiare negli sport voleva dire mostrare la potenza inarrestabile del proprio Paese così, in Est Europa, guidati dalla ferrea volontà di sottomettere il nemico occidentale, avviarono dei veri e propri programmi di Stato nei quali gli atleti venivano sottoposti a cicli continui di steroidi per incrementarne le prestazioni sportive.
Attraverso i decenni l’uso di anabolizzanti ha scavalcato i confini dello sport professionistico per approdare a quello amatoriale, nel quale si insegue un fine puramente estetico legato all’ottenimento di masse muscolari estremamente voluminose e al raggiungimento di percentuali di massa grassa più vicine possibile allo zero.
I livelli di utilizzo riguardano perlopiù la popolazione maschile e hanno raggiunto livelli così alti, soprattutto in America, da rappresentare oggi un grave problema sanitario, sociale e legale per via, non solo del traffico illecito, ma anche dei violenti crimini commessi a causa del massiccio utilizzo di questi farmaci.
Infatti, numerosi omicidi sono stati compiuti da soggetti che fino a quel momento non avevano mai mostrato tratti di personalità o segnali di disturbi che potessero renderli così aggressivi.
Dai benefici in ambito medico ai rischi per gli sportivi
Nonostante i rischi legati all’utilizzo di steroidi, la loro scoperta in ambito medico ha rappresentato un importante passo avanti per la terapia di alcune patologie che colpiscono soprattutto gli uomini come:
- Pubertà tardiva;
- Ipogonadismo, ovvero, incapacità dei testicoli di produrre una quantità adeguata di testosterone che causa problemi alla crescita, allo sviluppo e al funzionamento sessuale;
- Decadimento del corpo dovuto a malattie quali l’AIDS (https://www.msdmanuals.com/it).
La pressione sociale esercitata sugli atleti da cui si pretendono prestazioni fisiche non raggiungibili naturalmente, l’enorme giro di denaro generato dallo sport e l’esasperazione per via mediatica del concetto di bellezza estetica e del culto legato alla propria immagine ha trasformato il doping in un fenomeno endemico.
Anche se in termini di utilizzo non supera i numeri di altre sostanze nella popolazione adolescenziale, i dati cominciano a diventare preoccupanti quando si considera la popolazione di sportivi con stime che variano dal 20 al 50 percento degli atleti, soprattutto quelli che praticano bodybuilding.
Poiché l’uso di anabolizzanti prevede un effetto a lungo termine ed ha come scopo l’implementazione delle prestazioni sportive, non viene considerata una dipendenza, in quanto il fine del suo utilizzo non è quello di raggiungere uno stato alterato di coscienza, anche se ciò si verifica come controindicazione legata all’uso di queste sostante, come descritto in seguito.
Effetti della dipendenza da steroidi anabolizzanti
Per le ragioni appena citate, intercettare l’utenza e strutturare una terapia è molto complicato. Solitamente, quando i soggetti decidono di consultare un professionista mostrano già una quadro clinico molto grave, ovvero:
- Dipendenza (tolleranza, astinenza e craving) da steroidi;
- Sindrome maniacale (euforia, iperattività, senso di benessere, illimitata fiducia in se stessi) e ipomaniacale (irritabilità, alterazione dell’umore, deliri di onnipotenza) durante l’assunzione di steroidi;
- Deliri psicotici e allucinazioni;
- Assunzione continua di steroidi;
- Dismorfismo corporeo associato all’uso di steroidi;
- Coinvolgimento in crimini e atti violenti indotti dall’uso di steroidi.
Possibili cause della dipendenza da steroidi
Una percezione distorta della propria immagine gioca un ruolo fondamentale nella nascita e nel consolidamento della dipendenza. La costruzione di un corpo fuori misura, il più delle volte, viene considerato il mezzo più adeguato per ottenere un rispecchiamento positivo da parte degli altri (soprattutto dall’altro sesso).
Spingersi verso standard estetici sempre più estremi per compensare una bassa autostima non attenua la frustrazione nel vedersi inadeguati e nel notare, in maniera ossessiva, qualsiasi particolare del proprio fisico non in linea con i rigidi canoni di perfezione del culturista.
Vedersi e farsi vedere allenato rappresenta un rinforzo positivo così forte da oscurare il rinforzo negativo dato da una lunga serie di controindicazioni come disfunzioni sessuali, calvizie, atrofia testicolare, crescita del seno (negli uomini) e acne che deve essere contrastata mediante l’assunzione di ulteriori farmaci.
Va considerato che il dosaggio di steroidi, nella maggior parte dei casi, è totalmente arbitrario: le quantità assunte e il mix di sostanze varia sulla base del bisogno avvertito dal singolo individuo, scatenando effetti devastanti per il corpo (per esempio, tumori).
Inoltre, l’improvvisa crescita delle fibre muscolari può provocare forti dolori a tendini e muscoli che molti atleti devono tenere a bada assumendo antidolorifici, innescando così il pericolo concreto di essere colpiti da un’ulteriore dipendenza.
Cos’è la sindrome da sospensione?
È raro purtroppo che si parli dei rischi legati all’uso di anabolizzanti e lo è ancora di più per quello che riguarda la sindrome da sospensione, ovvero i sintomi che compaiono una volta che il soggetto smette di doparsi e sono:
- Stanchezza;
- Anoressia;
- Insonnia;
- Disturbi d’ansia;
- Deficit di concentrazione;
- Riduzione della libido;
- Depressione del tono dell’umore e ideazione suicida;
- Urgenza di assumere anabolizzanti (Brower, 2000 in Zappia – Montanari, 2008, 78).
Radici culturali dell’uso di steroidi
Numerosi studi hanno confermato quanto il problema legato all’uso di steroidi sia di gran lunga più presente in occidente piuttosto che in oriente anche e soprattutto per degli aspetti culturali legati al concetto di mascolinità e di bellezza estetica risalenti già ai tempi antichi della civiltà umana.
Se pensiamo alla mitologia, all’arte figurativa greca e romana e alla scultura gli eroi e le divinità erano sempre dotate di muscolature voluminose che dessero la misura del loro valore.
A prova di ciò basti semplicemente dire che nei miti scandinavi (paese con uno dei più alti livelli di consumo di steroidi) la muscolatura viene considerata una caratteristica appartenente agli dei vichinghi.
Giochi per bambini, immagini di corpi maschili sulle riviste, personaggi dei film di Hollywood (soprattutto supereroi) esercitano un’attrattiva così forte sul pubblico proprio per questa propensione all’azione e allo sforzo fisico da cui risale il potere di risoluzione dei conflitti.
La tradizione orientale, al contrario, possiede un’iconografia e delle immagini completamente differenti: le divinità come anche i guerrieri sono raffigurati sempre vestiti e con un corpo esile; infatti, nei film d’azione asiatici i protagonisti sono sempre campioni di arti marziali con una corporatura magra, come Bruce Lee e Ip Man, non vediamo mai un eroe con la corporatura di Conan il Barbaro.
Dai “Dialoghi di Confucio”, risalenti a più di 2000 anni fa, possiamo desumere come tradizionalmente la mascolinità non risieda nel semplice uso o sfoggio della forza fisica quanto piuttosto nell’intelletto, nella raffinatezza, e nella virtuosità.
Risulta ancora più evidente la discrepanza di visione, emersa in uno studio (Pope et al., 2000 in Zappia – Montanari, 2008, 80), sulla percezione da parte degli uomini dell’immagine muscolosa maschile come un elemento che possa attrarre le donne in vari paesi: uomini negli USA, Austria e Francia hanno selezionato un’immagine maschile con circa 10 kg di muscoli in più rispetto alla media di un uomo della loro società; mentre uomini di Taiwan hanno scelto un’immagine con poca massa muscolare aggiunta, riconoscendo che le donne non fossero attratte da un corpo maschile pieno di muscoli (Yang et al., 2005 in Zappia – Montanari, 2008, 80).
Come intervenire
Oltre ad uno psicoterapeuta in grado di trattare le dipendenze, è necessario attivare un lavoro di rete che coinvolga diversi professionisti. All’inizio della terapia, è importante coinvolgere un endocrinologo il cui contributo è reso necessario soprattutto dalla drastica riduzione della produzione endogena di testosterone.
Dal punto di vista psicologico è importante non trascurare, anche qui, il supporto dei farmaci antidepressivi al fine di contrastare gli effetti sull’umore causati dalla sindrome da sospensione.
Durante il corso della terapia, inoltre, il terapeuta dovrà avviare un’indagine sulla genesi del disturbo andando a modificare la percezione estremamente negativa che il soggetto ha del proprio corpo nonostante la dimensione dei suoi muscoli; individuare ed eliminare, insieme al paziente, tutti gli stimoli innescanti l’uso di steroidi; modificare le aspettative e le false credenze sugli effetti degli anabolizzanti e, infine, cambiare il rapporto patologico del paziente con lo sport promuovendo un approccio più sano che abbia come obiettivo una reale condizione di benessere, senza che il soggetto si senta costretto ad inseguire una forma fisica irrealizzabile.
Bibliografia
Contrò V. – Proia P. (2012), Conseguenze del doping da AAS: un overview sugli effetti a breve e lungo termine, in «Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo», 5, 1 (2), pp. 1 – 18.
Pacifici R. - Pichini S. - Martucci L. - Mastrobattista L. - Mortali C. - Solimini R. - Toth G. (2011), Droga e doping, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento del Farmaco.
Zappia M. A. – Montanari C. (2008), Dietro il doping, in «Integrazione nelle Terapie e nel Counseling», ASPIC Edizioni Scientifiche, 23-24, pp. 76 – 87.
Sitografia
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/normativa/le-sostanze/altre-sostanze/anabolizzanti/rischi/
https://www.psicologodibase.com/psicologia-e-territorio/159-vivere-male-il-rapporto-con-il-proprio-corpo-cosa-e-il-dismorfismo-corporeo.html