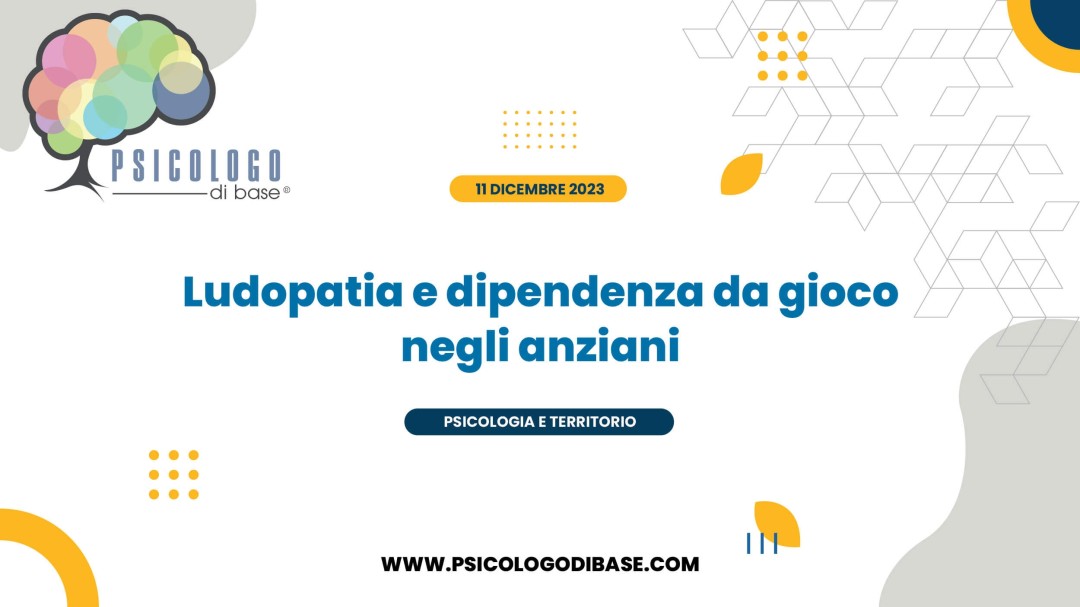Se hai raggiunto la pensione sai quanto l’assenza del tempo che prima dedicavi al lavoro lasci un vuoto nelle tue giornate.
Anche a livello familiare percepisci dei cambiamenti: i figli sono cresciuti ed autosufficienti, il tuo compagno o compagna di vita sta affrontando con te il nido che si svuota, l’età avanza e con essa possono insorgere nuovi dolori fisici e patologie.
Dal punto di vista relazionale la cerchia di amici e conoscenti si restringe ai più cari, e potrai essere costretto ad affrontare il tema del lutto.
Lavoro, famiglia, salute e relazioni sono ambiti di vita che si intrecciano nella definizione della nostra individualità: identifichiamo il nostro io con i ruoli che ricopriamo nelle varie sfere esistenziali: “sono una sarta”, “sono un padre”, “sono sana”, “sono suo amico”.
Nel momento in cui ci troviamo obbligati a ridefinirci dicendo: “ero una sarta”, “ero un padre”, “ero sano”, “ero suo amico”, dobbiamo affrontare la domanda: “adesso chi sono?”.
Perché si può scivolare nella dipendenza da gioco?
Se vogliamo capire perché per noi, un nostro familiare o un’amica, sia stato possibile scivolare nella dipendenza da gioco, dobbiamo prima capire che quando cambiano le coordinate che ci definivano all’interno degli ambiti della nostra esistenza, ci troviamo a vivere una situazione di stress che ci obbliga ad affrontare la metamorfosi tra l’io che eravamo e l’io che siamo diventati.
In particolare l’uscita dal mondo del lavoro è un passaggio critico: si ha a disposizione tempo e denaro ma si è svuotati della nostra precedente identità e soli di fronte al vuoto di non sapere chi siamo ora ed ecco perché è importante sapere cosa fare per riorganizzare la nostra vita dopo la pensione anche con i suggerimenti dei nostri psicologi e psicoterapeuti.
In questo momento della vita è complicato riconoscersi, e di fronte a questa difficoltà alcuni di noi possono sviluppare stati ansiogeni e/o depressivi. Il gioco d’azzardo funziona allora come un rimedio al sintomo che viene sedato dalla scarica data dall’emozione per una vincita che è statisticamente improbabile.
I fattori di rischio che aumentano la probabilità di scivolare nella dipendenza sono:
- l’allentamento delle responsabilità familiari, per esempio per l’indipendenza dei figli;
- la solitudine.
I campanelli d’allarme a cui prestare attenzione:
- smettere di prendersi cura di sé,
- sparire per lunghi periodi;
- avere gravi dimenticanze.
I comportamenti tipici del giocatore patologico
La ludopatia è arrivata a rappresentare un’emergenza sociale perché i comportamenti che la caratterizzano non si discostano da subito da quelli della vita di tutti i giorni.
I luoghi in cui è possibile giocare sono infatti spazi di aggregazione che tutti noi frequentiamo, come bar o tabaccherie. Tuttavia l’indagine dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) del 2018 rileva che questi sono i posti in cui gli anziani iniziano a giocare fino a raggiungere una frequenza allarmante, che arriva a condizionarne la vita quotidiana e ad alterarne i comportamenti.
Pur di continuare a giocare con gratta e vinci, slot machine, videolottery ed a puntare su scommesse sportive, si iniziano a chiedere prestiti, si vendono gli oggetti di valore appartenuti alla famiglia, le priorità cambiano e si può arrivare perfino a risparmiare sui ticket per le visite mediche. Gli ammanchi economici vengono nascosti ai familiari iniziando a mentire alle persone più care e vicine pur di riuscire a nascondere la propria dipendenza.
Queste alterazioni del comportamento nella persona si associano a:
- pensiero ossessivo del gioco;
- tendenza a spendere cifre elevate in giochi con minime probabilità di vittoria;
- tendenza a minimizzare le perdite e a ricordare le vincite;
- senso di colpa e depressione per aver perso grosse cifre o aver contratto debiti;
- l’incapacità di resistere al gioco, nonostante la sincera volontà di astenercisi.
Cosa accade nel cervello di un giocatore compulsivo
Quando gioca, il cervello del soggetto ludopatico rilascia una gran quantità di dopamina, innescando il processo di gratificazione; il giocatore cercherà di riprodurre questa sensazione con una nuova vincita scommessa dopo scommessa, in un circolo ripetitivo.
Nello studio di Nigro e colleghi del 2022, gli autori hanno rilevato in chi gioca da diversi anni un aumento:
- del coinvolgimento nel gioco;
- delle distorsioni cognitive associate al gioco d’azzardo patologico (GAP o gambling).
Dove con distorsioni cognitive si intendono le disfunzionalità del ragionamento, per cui si può essere portati a credere che il proprio comportamento influenzi gli esiti della giocata, per esempio quando pensiamo che otterremo un numero più alto al tiro ai dadi lanciandoli con maggior potenza.
Al contrario, non si registra nessuna riduzione della propensione al rischio nei giocatori abituali.
Questo significa che negli anni le persone sviluppano la tendenza a continuare a giocare, e in particolare gli anziani che giocano finiscono col perdere più soldi in minor tempo.
Nuove ricerche stanno oggi approfondendo:
- le capacità decisionali dei giocatori;
- il fenomeno del chasing: il cercare di rimediare alle perdite continuando a giocare;
- il fenomeno dei bias attentivi: un’alterazione dell’attenzione per gli stimoli di gioco a cui il giocatore è più sensibile.
Le specificità della terza età
Tutti i periodi del ciclo di vita di ogni essere umano sono caratterizzati da specificità, perché le caratteristiche che ci contraddistinguono in una certa fascia d’età assolvono a compiti evolutivi diversi per ogni momento della nostra esistenza: così il bambino è diverso dall’adolescente, dall’adulto e dall’anziano.
Quando si parla di gioco d’azzardo negli anziani si fa riferimento a persone con più di 65 anni d’età. Ci si auspica che questo periodo della vita sia caratterizzato dalle esperienze maturate negli anni, dalla stabilità e dall’accettazione. Tutti questi fattori concorrono alla strutturazione di un’identità solida, che stabilizza il più possibile il nucleo personale di ognuno di fronte ai cambiamenti che possono sopraggiungere e che fisiologicamente in questo periodo della vita riguardano spesso lo stato di salute proprio o dei propri cari.
D’altro canto queste stesse tendenze fanno sì che nel caso in cui la persona debba affrontare un cambiamento la sua motivazione, aderenza ad eventuali trattamenti e fiducia nei caregiver (le persone che si prendono cura di lui) o negli operatori, sia tutta da costruire, spesso con difficoltà.
Ecco perché, nel caso di una diagnosi da dipendenza e in particolare da gioco d’azzardo patologico, sia spesso difficile coinvolgere gli anziani nei percorsi riabilitativi: l’anziano è ancorato a un’idea di sé precedente allo sviluppo della dipendenza, e difficilmente si rivolgerebbe al Serdp (Servizio per le Dipendenze), un servizio che tendenzialmente associa al trattamento degli usi degli stupefacenti, in cui non si riconosce perché non associa la pericolosità del gioco al mondo delle dipendenze.
Oltre la ludopatia: capire per curare
Oggi lo stigma è ancora molto forte: il giocatore è visto come uno che butta via i soldi e questo rafforza in chi gioca il senso di vergogna, la chiusura verso gli altri e il rifiuto per l'idea di essere diventato dipendente dal gioco compulsivo.
Invece, che il gioco d’azzardo sia una malattia ce lo dicono non solo gli studi, ma anche la legge: il Decreto Balduzzi del 2012 inserisce tra le patologie in carico al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) la dipendenza dal gioco d’azzardo, includendola nell’elenco delle dipendenze trattate dai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) per cui si può accedere ai servizi di consulenza, diagnosi e terapia col solo pagamento del ticket sanitario.
Capire di avere un problema è il primo passo per intraprendere il percorso di cura, per questo è fondamentale sensibilizzare la popolazione e cercare di avvicinare le persone senza spaventarle, tanto che in questi ultimi anni sono nate delle figure professionali chiamate tipster che, come i broker, scommettono per i propri clienti gestendo il loro portafoglio e uno dei più famosi, Francesco Bove, ha scritto un libro dedicato a questo argomento con consigli sulle risorse che possono aiutare a valutare le abitudini di gioco e prevenire la ludopatia.
Piuttosto bisogna cercare di farsi accettare creando una rete sociale di supporto all’anziano che egli possa riconoscere come familiare, averne fiducia, e favorire lo scambio tra diversi settori professionali per favorire una presa in carico integrata basata sul dialogo tra i servizi per le dipendenze, quelli di salute mentale, e quelli per gli anziani non autosufficienti.
A chi rivolgersi per combattere la ludopatia
Oggi tutti, sia che siano giocatori diretti o familiari di un giocatore, possono informarsi sulla piattaforma online Uscire dal Gioco o contattare il Telefono Verde Nazionale 800 558822 per ricevere aiuto.
Inoltre esistono già molteplici vie che i giocatori patologici possono intraprendere per uscire dal gioco compulsivo:
- gruppo di auto-mutuo-aiuto per giocatori d’azzardo patologici condotti da un educatore e uno psicoterapeuta;
- percorso ambulatoriale: sedute di psicoterapia, abbinate ad incontri di gruppo, sostegno ai familiari e supporto legale per sistemare la situazione finanziaria compromessa dal gioco;
- terapia occupazionale: per ritrovare il proprio equilibrio tornando ad usare le mani ed apprezzare le cose semplici della vita;
- percorso residenziale: che prevedono la possibilità di vivere per un periodo in una comunità di recupero.