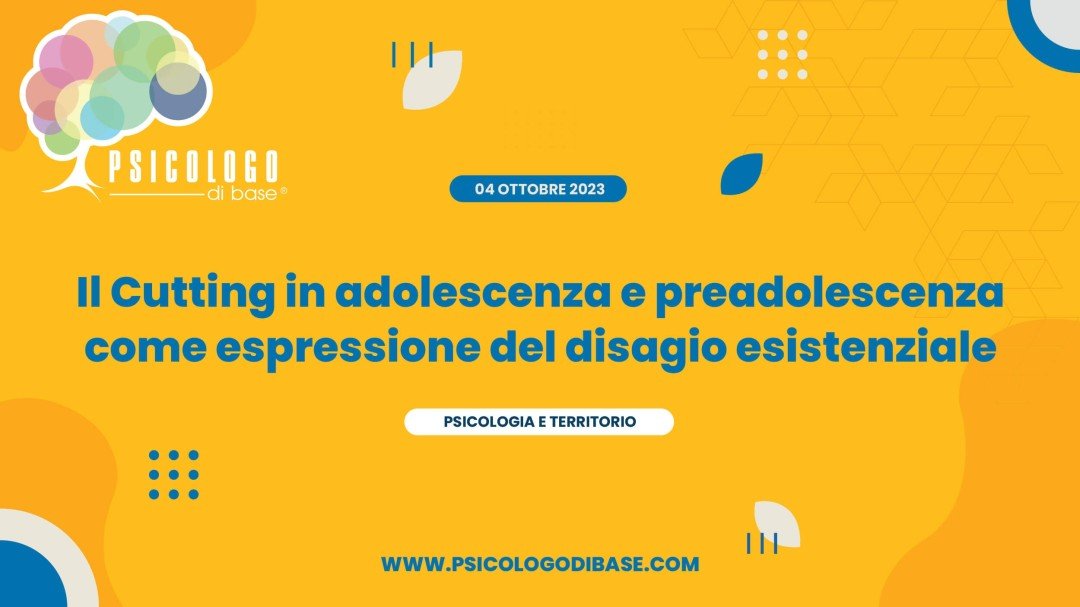Il cutting ed in generale tutte le condotte autolesive non suicidarie, possono essere considerate una manifestazione comportamentale disfunzionale di tentativi di regolazione emozionale, in particolare dell’angoscia. Sembra dunque comprensibile come, tra le popolazioni più a rischio per autolesionismo non suicidario, compaiano gli adolescenti in una percentuale di circa il 17,2%.
Cosa è il cutting l’autolesionismo adolescenziale
Con il termine cutting o self cutting ci si riferisce ad una pratica di autolesionismo volontario che prevede il tagliare (cutting), ferire e l’incidere la pelle del proprio corpo attraverso strumenti come lamette, coltelli, lame di temperamatite o altri oggetti affilati.
Oltre al cutting, nelle forme di autolesionismo non suicidario rientrano anche comportamenti autoinflitti come:
- graffi,
- ustioni,
- ematomi
- morsi
Questi agiti hanno generalmente l’obiettivo di ridurre o comunicare all’esterno una tensione interna angosciosa, che viene vissuta come insopportabile.
Diversamente dall’ansia che può essere considerata anche adattiva, in quanto rappresenta la risposta psichica della persona a qualsiasi stimolazione esterna di pericolo, l’angoscia è uno stato di allarme logorante, caratterizzato da impotenza pervasiva e da afinalismo comportamentale.
Il disagio esistenziale in adolescenza e preadolescenza
L’adolescenza rappresenta il passaggio dall’infanzia all’ingresso nell’età più adulta ed è considerato un periodo evolutivo di forti cambiamenti, vere e proprie crisi che necessitano di una riorganizzazione dell’immagine del sé non più bambino.
L’inizio di questa fase coincide generalmente con i cambiamenti fisiologici puberali rispetto la comparsa dei caratteri sessuali secondari, come la crescita dei genitali esterni nei ragazzi e la comparsa del menarca nelle ragazze. Alcuni cambiamenti invece riguardano la sfera cognitiva.
L’adolescente di fatto è capace, poiché assimila il pensiero operatorio formale, di formulare giudizi ipotetici e completamente astratti. Ciò gli consente dunque di ragionare sulla propria percezione del mondo, sia quella vissuta internamente che la percezione delle situazioni esterne, dando quindi un significato più profondo alle esperienze vissute.
Tra le esperienze interne vissute in adolescenza, la ricerca della propria identità assume un ruolo fondamentale. Percepirsi come Sé stabile e coerente, con valori e capacità uniche e differenti dal contesto familiare è la sfida cui l’adolescente va incontro.
Egli sperimenta nuovamente il processo d’individuazione - separazione, un processo psico-emotivo che consente all’uomo d’identificarsi come persona autonoma con desideri, bisogni ed obiettivi propri e specifici.
Questo processo viene messo in atto dall’adolescente attraverso un disinvestimento affettivo nei confronti dei genitori. Dunque i bisogni di riconoscimento ed approvazione, sicurezza e protezione, sono in adolescenza direzionati verso nuove figure, ovvero il gruppo dei pari, all’interno del quale egli può sperimentarsi come individuo autonomo (Peter Blos 1962).
Il compito evolutivo dello sviluppo della propria identità è opposto al processo di dispersione del Sé, dove l’adolescente non riesce a gestirsi ed organizzarsi in una struttura stabile, all’interno del quale i diversi aspetti del Sé sono percepiti come non conciliabili.
Quindi il compito di costruzione di un’identità rappresenta un rischio per l’adolescente di sviluppare nel corso del tempo condizioni di malessere che possono strutturarsi in veri disturbi psicopatologici.
Infatti, proprio perché il processo di riorganizzazione del Sé risulta emotivamente molto impattante può essere vissuto dall’adolescente in maniera estremamente angosciosa, un vero e proprio disagio esistenziale.
Regolazione emotiva e cutting come strategia di pseudo-regolazione
La gestione dell’angoscia riferita al processo di riorganizzazione del Sé diventa per l’adolescente prioritaria. Ma come avviene il processo di gestione dell’angoscia, ed in generale di tutte le emozioni?
La gestione e regolazione emotiva viene attuata per mezzo di un processo cognitivo-emotivo chiamato regolazione emotiva, attraverso il quale “gli individui comprendono quale emozione stanno provando, quando la provano e come riescono a farne esperienza e ad esprimerla” (Gross, 1998, pp. 275).
Essa è dunque la capacità di una persona di gestire le emozioni sia positive che negative, aumentando o abbassando il livello di attivazione delle stesse. Nell’attuazione di questo processo, per modificare l’espressione delle emozioni, le persone si servono di diverse strategie, sia in modo consapevole sia attraverso automatismi non consci.
Alcune strategie, come quelle di selezione e modifica della situazione, agiscono in maniera diretta sull’evento che ha provocato una determinata emozione. Ad esempio una persona, per evitare di imbattersi in una situazione spiacevole, modifica attivamente la situazione stessa, tentando di ridurre al minimo le possibilità d’incontro con essa.
Invece le strategie di modulazione della risposta agiscono direttamente sull’espressione dell’emozione stessa, modificandone l’impatto percepito. Tecniche di rilassamento oppure l’utilizzo di una sostanza esterna come le droghe, l’alcool o il cibo, agiscono sull’intensità emotiva modificando il vissuto soggettivo percepito.
Ed è proprio in questo senso che le diverse pratiche di autolesionismo volontario non suicidario possono essere identificati come comportamenti disadattivi volti a modulare la risposta emotiva dell’angoscia percepita.
Infatti il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V, APA, 2013) descrive nel seguente modo i criteri per fare diagnosi di autolesionismo non suicidario (ANS):
A. Il soggetto, in 5 o più episodi nell’ultimo anno, danneggia intenzionalmente la propria superficie corporea o cerca di indurre sanguinamento, lividi o dolore, con l’aspettativa che la condotta autolesiva comporti solo danni fisici di lieve o moderata entità (non vi è alcun intento suicida).
B. La condotta autolesionistica si presenta con una o più delle seguenti aspettative:
- Ottenere sollievo da emozioni e stati cognitivi negativi;
- Risolvere difficoltà interpersonali;
- Indurre stati emotivi positivi.
C. L’autolesionismo intenzionale è associato ad almeno una delle seguenti condizioni:
- Difficoltà interpersonali, sentimenti o pensieri negativi, come depressione, ansia, tensione, rabbia, angoscia generalizzata o auto-critica, che si verificano nel periodo immediatamente precedente l’atto autolesionistico.
- La realizzazione dell’atto autolesivo è preceduta da preoccupazioni circa la difficoltà di controllare il comportamento previsto.
- La presenza di pensieri frequenti sull’autolesionismo, anche quando non viene messo in pratica.
Sono dunque gli stessi criteri d’identificazione dell’autolesionismo che mettono in evidenza la valenza di questo comportamento disfunzionale come un agito volto alla regolazione emotiva.
Come si cura il cutting: strategie adattive di regolazione emotiva
Avendo chiarito in parte le motivazioni simboliche che assumono le condotte di autolesionismo non suicidario, si delinea la necessità di chiarire quali siano le strategie alternative per l’adolescente di esprimere l’angoscia che il processo di riorganizzazione del Sé determina.
Indubbiamente il primo passo da compiere è prendere consapevolezza del comportamento problema, contattando un professionista esperto che possa aiutare l’adolescente a chiarire i significati unici e personali che i gesti autolesivi mascherano, all’interno di un progetto terapeutico finalizzato ad evitare la cronicizzazione del disturbo e che sostenga tutta la rete familiare.
Infatti la famiglia gioca un ruolo attivo nella diminuzione dei comportamenti autolesivi. Tra le strategie di regolazione emotiva, la ricerca attiva del supporto sociale, che sappia fornire sostegno durante il tumulto emotivo interiore, è considerata fortemente efficacie. La famiglia può e deve diventare il luogo all’interno del quale i sentimenti angosciosi possono essere vissuti dall’adolescente senza essere negati o minimizzati ma invece compresi ed accolti.
Nelle scienze umane il supporto sociale viene definito “dalle risorse psicologiche e materiali da parte della rete sociale, mirate a sostenere l’individuo nella sua abilità di far fronte allo stress” (Cohen, 2004). Tra le risorse psicologiche è la famiglia la prima rete sociale che ha il compito di fornire empatia, amore, fiducia, cura.
Tuttavia anche i familiari, dopo essere venuti a conoscenza del comportamento disfunzionale, vivono una condizione emotiva di confusione ed incredulità. L’intervento del professionista deve essere dunque finalizzato su tutto il sistema, che necessita di un aiuto nel ripristinare la propria funzione supportiva. È nel momento in cui l’adolescente si sente libero di esprimere i propri vissuti angosciosi che possono essere abbandonati le modalità disfunzionali di regolazione emotiva rappresentate dal cutting.
Un’altra strategia adattiva per gestire le emozioni è la ristrutturazione cognitiva, che assume una valenza preponderante in adolescenza. Si tratta infatti della possibilità di ridurre gli stati emotivi negativi andando a modificare il significato dell’evento stesso, attraverso la creazione di nuove interpretazioni.
Questo tipo di strategia risulta particolarmente efficacie per gli adolescenti, in quanto opera un empowerment delle capacità metacognitive, ovvero delle capacità di riflettere su sé stessi, i propri pensieri e le proprie emozioni.
Aumenta quindi la consapevolezza della propria soggettività, andando a ridurre il rischio di dispersione del Sé e la possibilità di essere travolti dall’emozione. L’emozione può essere dunque gestita internamente e non proiettata e agita sul corpo.
- American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2014
- Blos, P. (1962). On adolescence. New York: Free Press, trad. it: L’adolescenza. Una interpretazione psicoanalitica, 1993, Milano, Franco Angeli
- Cohen S. (2004), “Social relationships and health”, American psychologist, 59(8), 676.
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299
- Invernizzi G., Bressi C., (2012) Manuale di Psichiatria e psicologia clinica, The McGraw-Hill Companies, Milano.
- Nock, M. K. (2010). Self-Injury. Annual Review of Clinical Psychology, 6(1), pp. 339–363 review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299.
- Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: systematic review, meta-analysis and meta-regression. Suicide & life-threatening behavior, 44(3), 273–303.
- Tronick E., (2008). Regolazione emotiva, Raffaello Cortina.