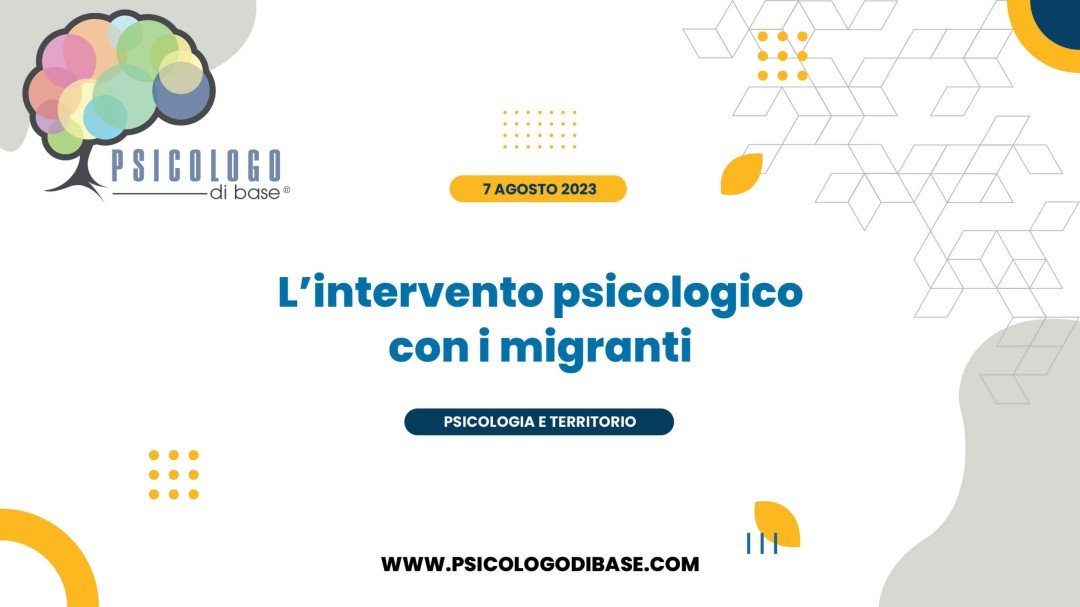L’esperienza della migrazione, di cui solo poche settimane fa abbiamo ricevuto notizia dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo, è caratterizzata dall’essere composta da più livelli tra loro interconnessi, come dimostra l’attenzione che i media prestano al fenomeno.
Dal punto di vista politico la migrazione è tra i temi centrali del dibattito presso il Parlamento Europeo, mentre molti dei suoi stati interni, tra cui Italia e Francia, si confrontano duramente e a più riprese a seguito delle posizioni speculari dei due capi di stato Meloni e Macron.
L’incontro coi migranti oggi
Oggi l’incontro con una persona arrivata tramite un percorso migratorio è esperienza comune a quasi ognuno di noi, e come ogni incontro con l’Altro, suscita percezioni soggettive. Tuttavia l’incontro col migrante porta in sé una specifica maggiore perché ci pone di fronte a un umano culturalmente diverso da noi e questo attiva una serie di stereotipi condizionati dalla nostra stessa cultura di appartenenza, di cui siamo scarsamente coscienti, così come teorizzato da Lippmann nel 1922.
Le politiche del Paese in cui il migrante arriva possono descrivere i flussi migratori come risorse o come minacce a seconda che l’immigrato sia visto come portatore di indotto al sistema nazionale o come un costo.
Per esempio: i flussi migratori sono stati considerati positivamente dalla politica europea nel boom economico del dopoguerra quando si necessitava di molta manodopera per la ricostruzione. Successivamente, invece, a livello globale si sono progressivamente adottate politiche volte a legittimare l’accoglienza del migrante solo nella misura in cui egli abbia il diritto di accedere allo status di rifugiato secondo la definizione della convenzione ONU di Ginevra del 1951.
Oltre ai provvedimenti legislativi si sono sviluppati interventi fisici come la costruzione di muri alle frontiere europee per recintare il continente e favorire i respingimenti. Tuttavia i processi migratori continuano a prescindere dalle politiche adottate, come descritto dall’ISPI (l’Istituto per gli studi di politica internazionale).
L’accesso ai servizi
Le politiche non influenzano solo gli stereotipi personali, ma cambiano anche i servizi assistenziali in cui lavorano educatori ed operatori socio-assistenziali, servizi psicologici, psicoterapeutici e psichiatrici presenti sul territorio nazionale a cui gli utenti migranti possono accedere, come evidenziato da Ticktin.
Attualmente in Italia è il servizio pubblico sanitario ad intercettare per primo la domanda di cura dei migranti i cui disagi, sofferenze e disturbi mentali sono riconducibili agli eventi di vita che spesso comprendono:
- i traumi subiti nel Paese d’origine che includono spesso schiavitù, tortura, abusi e violenze;
- i traumi nel percorso migratorio gestito da trafficanti di uomini per cui chi riesce ad arrivare è a tutti gli effetti un sopravvissuto ad amici, fratelli, parenti, con tutte le sequele psicologiche che da questo derivano;
- i respingimenti operati alle porte dell’Europa;
- i vissuti di solitudine e incertezza per il protrarsi dell’attesa nelle strutture governative di prima accoglienza;
- l’esperienza di una vita sospesa nell’irregolarità senza diritti né doveri nel caso di rifiuto dello status di rifugiato politico.
Da qui deriva una sintomatologia complessa, difficilmente comprensibile agli operatori di servizi in primis perché sprovvisti di mediatori culturali che rendendo all’utente difficoltosa l’espressione della sofferenza provata, e secondariamente perché non competenti dal punto di vista storico-antropologiche per arrivare a comprendere i riferimenti e le espressioni tradizionali del Paese d’origine a cui spesso ricorre l’utente per descrivere il proprio disagio. In queste condizioni il rischio derivante dall’ignorare la specificità di questo target è quello di non vedere il significato del sintomo incarnato nel paziente. Conseguentemente l’utente, non sentendosi accolto, tende ad abbandonare la presa in carico.
A questo punto inizia un pellegrinaggio presso altri centri del territorio cercando alternative efficaci di cura a fronte di manifestazioni sintomatiche che possono intensificarsi e cronicizzarsi per cui l’utente può arrivare a richiede o a necessitare di ripetuti ricoveri o accessi al pronto soccorso, andando a sovraccaricare un servizio già di per sé in difficoltà (Ponzio e Visentin, 2003).
Presentazione di un caso clinico: il supporto psicologico al migrante
Mme B (così la chiameremo), è una paziente africana immigrata in Francia e presa in carico da un servizio psichiatrico francese denominato UMAPP (Unità Mobile di Azione Psichiatrica in contesti di Precarietà) facente parte dell’Ospedale Psichiatrico CH du Rouvray a Rouen. L’équipe dell’UMAPP è composta da psichiatri, psicoterapeuti ed infermieri.
L’équipe multidisciplinare ha ritenuto di attivare per Mme B una presa in carico psicoterapeutica, in quanto al momento dell’inizio del percorso Mme B era incinta e quindi non poteva assumere psicofarmaci.
Quando ho incontrato Mme B e la sua psicoterapeuta, il loro percorso durava da circa due anni. Durante questo lasso di tempo, Mme B aveva ricevuto il rifiuto della sua richiesta di rifugiata e per questo si trovava in posizione irregolare in Francia con il figlio di pochi mesi. Entrambi erano temporaneamente accolti presso un Centro d’Accoglienza d’Urgenza senza sapere se e quando sarebbero stati rimpatriati nel loro Paese d’origine e nell’attesa senza diritto di lavoro né altri servizi.
Mme B. venne indirizzata all’UMAPP dal medico di base a cui si rivolse per “un problema di violenza” subito nel suo Paese d’origine che le causava ricorrenti incubi, frequenti risvegli e flash-back in cui rivedeva le immagini dei violentatori come se essi fossero presenti nel qui ed ora, in Francia, facendole rivivere la paura e la violenza subita. In questo periodo in cui i vissuti traumatici erano particolarmente attivi, M.me B descrive la sua sofferenza come incomunicabile agli altri, dicendo che: ‘’tu soffri dentro senza poter parlare’’.
Origine della sofferenza di Mme B è il trauma per la violenza vissuta al Paese d’origine. Il traumatismo le ha causato una frattura che incarnandosi nella paziente provoca una ferita all’integrità psico-fisica nella quale si è inserito un peso esterno che blocca M.me B togliendole la capacità di parlare: “sono ferita per tutto quello che ho vissuto (…) direi che ho un peso di cui non posso parlare”. La ferita, pur non avendo lasciato tracce fisiche, riproduce i propri effetti nei continui incubi e nel ritorno delle immagini dei violentatori (Nathan ‘’La folie des autres’’, 1986). Le percezioni alterate di Mme B nel qui ed ora indicano lo stato di crisi in cui la paziente si trova, dove l’elemento dominante è la confusione tra il tempo passato in cui il trauma è avvenuto e il momento presente in cui il soggetto reitera le violenze subite alterando le proprie percezioni.
Servizio psicologico nel sistema di accoglienza: l’interpretazione della sofferenza
Dalle interviste condotte alla paziente e alla sua psicoterapeuta, emergono sia punti di lettura comuni che differenze interpretative.
Queste similitudini e differenze sono importanti perché da un lato le similitudini hanno permesso di riconoscere lo stato di sofferenza della paziente, che descrivendo i propri incubi ha permesso alla psicoterapeuta di individuare degli “invarianti culturali”, cioè degli elementi dell’umanità dell’altro che indicano universalmente i conflitti umani, a prescindere dall’appartenenza culturale (“La folie des autres’’ Nathan, 1986).
Distinte sono le interpretazioni relative al ruolo che la parola viene ad assumere nel lavoro clinico, in linea con le diverse conoscenze culturali e teoriche di riferimento delle due intervistate:
- per l’operatore il ripercorrere ed esprimere gli eventi passati permetterebbe un’elaborazione attraverso cui il paziente arriverebbe ad interrogarsi sul proprio funzionamento, al fine di acquisire maggiori ambiti d’azione;
- per l’utente migrante la parola rappresenta l’oggetto di transizione tra l’interno e l’esterno, oggetto attraverso cui sarebbe possibile esteriorizzare il peso che le grava dentro.
Durante il lavoro psicoterapeutico la psicoterapeuta adotta una posizione totalmente estranea rispetto all’identità ferita di M.me B. Questa totale estraneità consente alla paziente di “ricevere consiglio” su come esprimere la propria sofferenza attraverso un percorso che sposti l’altro e i suoi effetti nel mondo esterno, rendendolo controllabile attraverso le proprie azioni e restituendo quindi alla paziente l’esperienza di essere soggetto attivo e non più vittima passiva dell’altro.
Questo genera un movimento trasformativo dal dentro al fuori (Zempleni) veicolato attraverso la parola, che si evolve durante l’intero percorso e va a ricostruire il limite tra io e l’altro, riposizionando l’alterità al di fuori di M.me B. Questo movimento consente a M.me B di sentirsi sollevata durante i colloqui con la psicoterapeuta in cui progressivamente costruisce la sua nuova identità comunicabile e condivisibile con l’altro perché non più bloccata dagli effetti del trauma.
Conclusioni ed approcci teorici: la psicologia della migrazione in frontiera
Trattare efficacemente questo specifico target richiede servizi antropologicamente competenti e operatori che sappiano ricorrere ad una specifica semiologia che consideri le specificità dei migranti per comprenderne la sofferenza e renderne traducibili i sintomi in un quadro narrativo di significato, instaurando con l’utente una relazione terapeutica che consenta l’accesso ai sistemi di cura ed assistenza ed eviti l’abbandono della presa in carico da parte di questo tipo di utenza.
Nel setting della presa in carico psicologica l’incontro coi migranti ha bisogno di articolarsi in un orizzonte di possibilità definito da due teorie cardinali:
- la teoria della cultura (Devereux) per approcciarsi alla sintomatologia portata dalla popolazione immigrata considerandone la specifica Cultura nel contesto del Paese di arrivo della migrazione;
- la teoria della differenza culturale (Bastide) che mette in luce i fenomeni dell’acculturazione bidirezionale che avviene nell’incontro tra persone appartenenti a diverse culture.
Questi presupposti permettono di costruire matrici culturali sulle quali far leva per lavorare sul sintomo portato dal paziente e favorirne il cambiamento (Beneduce).