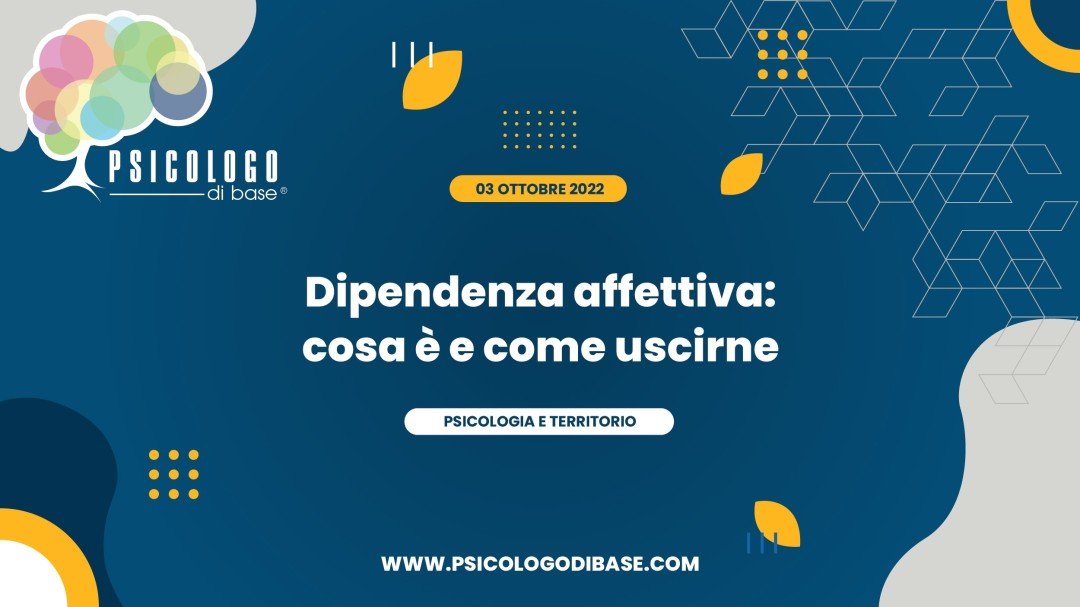Ti è mai capitato di sentirti così coinvolto in una relazione tanto da non riuscire a fare o a pensare ad altro? Oppure di giustificare i malumori del tuo partner, di nascondere agli altri e a te stesso i suoi difetti? E ancora: hai mai desiderato essere diverso (più buono, più attraente, più intelligente) così che lui/lei potesse amarti di più?
Se la risposta è sì, allora molto probabilmente hai vissuto (o stai vivendo) una storia che ti ha reso euforicamente felice al suo esordio, ma poi ti ha come gettato lungo un precipizio del quale non sembrava esistere il fondo.
Avrai avuto la sensazione di non essere mai abbastanza, di dover mostrare la tua dedizione ogni volta un po’ di più, di tremare dal terrore all’idea di perdere il tuo partner. In poche parole, hai vissuto una dipendenza affettiva.
Cosa è una dipendenza affettiva o love addiction
Nel DSM-V (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), oggi giunto alla quinta edizione, la dipendenza affettiva (love addiction) non trova ancora riconosciuto lo status di disturbo a sé, in quanto la letteratura scientifica non dispone di dati e ricerche sufficienti.
È significativo, però, che la love addiction rientri nell’elenco delle New Addictions, cioè in quei comportamenti socialmente accettati il cui perpetuarsi ossessivamente nel tempo porta l’individuo a perdere il controllo della propria vita.
Tra le New Addictions troviamo la dipendenza da gioco d’azzardo, la dipendenza da shopping compulsivo, da sesso, dalle tecnologie e, per l’appunto, la dipendenza affettiva.
La psicologa Ameya Gabriella Canovi, esperta di dipendenze affettive, definisce così la love addiction: è «un disturbo della relazione caratterizzata da un attaccamento morboso e ossessivo a un’altra persona che non ricambia e non manifesta la nostra stessa intensità».
Non si tratta, quindi, di una malattia, bensì di un disagio relazionale il cui sviluppo presenta caratteristiche molto simili a quelle di una dipendenza da una sostanza.
Come si riconosce la dipendenza affettiva
È molto difficile, però, riconoscere una dipendenza affettiva, per due motivi:
- Non si manifesta in maniera eclatante: resta silente, a volte per molto tempo.
- La cultura nella quale siamo immersi promuove un’idea dell’amore quale sentimento ed esperienza che inevitabilmente comporta dolore e sacrificio.
Si pensi ai libri, ai film, alle canzoni che raccontano l’amore. A titolo esemplificativo, ne citiamo una che recita: “io che non vivo più di un’ora senza te, come posso stare una vita senza te”.
Comprendere le origini e le manifestazioni della dipendenza affettiva consente di fare un primo step verso la guarigione. Non si può pensare di uscire da queste relazioni continuando a puntare il dito contro l’altro.
Scaricare la responsabilità del nostro benessere sulle spalle del partner è la ripetizione di una modalità relazionale disfunzionale che abbiamo probabilmente acquisito durante l’infanzia e che ci ha permesso di sopravvivere fino a quel momento. Perché abbandonarla, dunque?
Così, il dipendente affettivo è il portatore sano di un problema relazionale, che riguarda prima di tutto il rapporto con se stesso. Solo in seguito trova la sua espressione nella relazione con l’altro. È uno sguardo rivolto sempre all’esterno e mai dentro di sé.
Dipendenza affettiva come uscirne
Cosa fare, allora? Bisogna innanzitutto sostenere un’educazione che ci orienti verso la concezione di noi stessi quali individui interi, autonomi, indipendenti, completi. Non siamo la metà di una mela. È necessario assumersi la responsabilità della propria felicità, fare pace con un passato a volte molto doloroso, diventando la base sicura di se stessi. Significa chiedersi cosa, dentro di noi, porta a questa condizione.
Come già citato in precedenza, esistono ancora pochi dati sulla dipendenza affettiva, quindi al momento non si dispone di informazioni adeguate e consolidate riguardo al trattamento di questo disagio relazionale.
Una ricerca pubblicata sull’Evaluation & the Health Professions nel 2010 dichiara che la prevalenza della dipendenza affettiva nella popolazione statunitense è stimata intorno al 3%; tale percentuale sale al 25% se si considerano gli studi su popolazioni specifiche, quali gli adolescenti.
Si tratta, pertanto, di un disturbo relazionale che impatta sulla vita di molte persone e che, se non riconosciuto e curato tempestivamente e in maniera adeguata, può tradursi in un disagio importante e/o in un disturbo mentale.
Il trattamento clinico della dipendenza affettiva prevede la progettazione di interventi psicosociali quali i gruppi di auto-aiuto, la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoterapia psicodinamica e la psicoterapia di gruppo con psicodramma.
Tra questi, l’intervento più utilizzato è quello dei gruppi di auto-aiuto, ma al momento non esistono dati sufficienti che consentano di indicare un trattamento d’elezione.
Bibliografia
- Bowlby, J. (1989). Una base sicura: Applicazioni cliniche della teoria dell ’attaccamento. Milano: Raffaello Cortina.
- Canovi, G. A. (2022). Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva. Milano: Sperling&Kupfer.
- Norwood, R. (1989). Donne che amano troppo. Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore.
- Sanchesa, M. & Johnb, V.P. (2018). Treatment of love addiction: Current status and perspectives. The European Journal of Psychiatry, 33(1), 38-44.
Sitografia
- Canovi, G. A. Di troppo amore – Ameya Canovi.