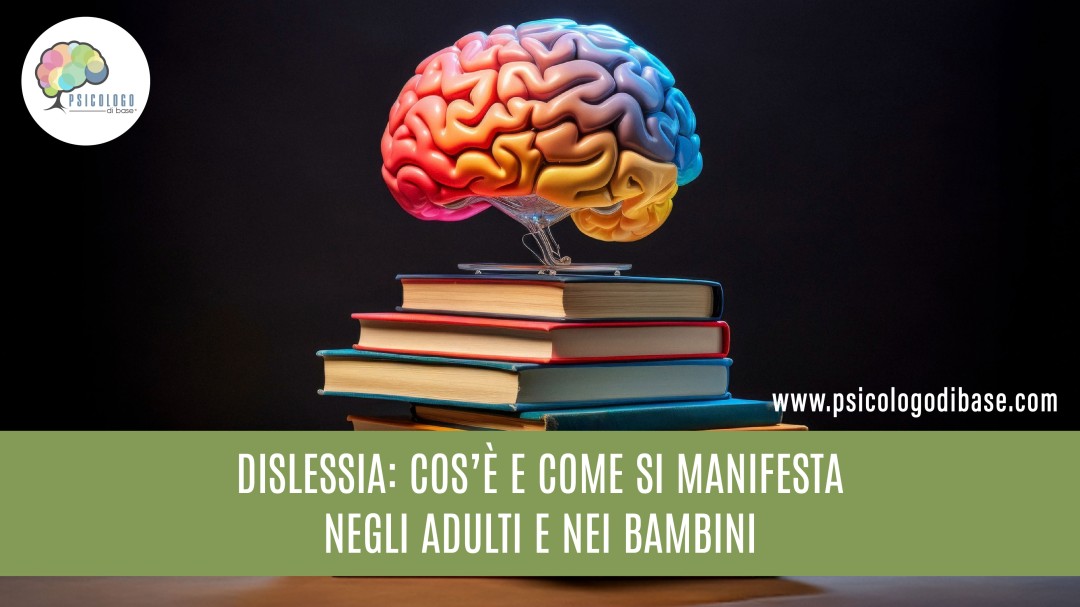- Che cos’è la dislessia e cosa significa essere dislessici?
- Come riconoscere i sintomi della dislessia nei bambini?
- Come si manifesta la dislessia negli adulti?
- Come diagnosticare la dislessia?
- Dislessia e scuola: cosa fare per aiutare un alunno con DSA?
- Strategie pratiche per studiare con la dislessia
- Domande frequenti sulla dislessia (FAQ)
- La dislessia non dipende dall’impegno, ma dal modo in cui il cervello elabora la lettura e la scrittura.
La dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) che riguarda in modo particolare la lettura: la sua accuratezza, la velocità e la comprensione. Non è legata all’intelligenza né alla volontà: bambini e adulti dislessici sono perfettamente capaci di apprendere, ma hanno un modo diverso di elaborare le informazioni scritte. La dislessia non è una malattia, non è colpa di nessuno, e soprattutto non definisce il valore o le potenzialità di una persona.
Mio figlio ha difficoltà a leggere: potrebbe essere dislessia?”
Questa è una delle domande più frequenti che ricevo nello studio, spesso carica di preoccupazione, ma anche di speranza. I genitori notano che qualcosa non torna: il loro bambino è curioso, intelligente, pieno di risorse, eppure leggere sembra una fatica enorme. Le lettere si confondono, la lettura è lenta, spezzata, e i compiti diventano ogni giorno una sfida. E a volte, non sono solo i bambini a far sorgere dubbi. Molti adulti, dopo anni trascorsi a convivere con difficoltà mai davvero comprese, iniziano a chiedersi se quei problemi con la lettura, la scrittura o l’organizzazione dello studio possano finalmente avere un nome.
Oggi vedremo insieme come riconoscerla, a chi rivolgersi per la diagnosi e quali strategie di studio possono rendere l’apprendimento più accessibile, sereno ed efficace.
La dislessia non deve limitare il tuo potenziale.
Prenota un consulto con un esperto di Psicologodibase.com e scopri le strategie giuste per affrontarla con serenità
Che cos’è la dislessia e cosa significa essere dislessici?
La dislessia, come abbiamo detto, è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) che riguarda in modo particolare la capacità di leggere in modo corretto e fluente. Le persone dislessiche possono incontrare difficoltà nel riconoscere e decodificare le parole scritte, nel leggere con velocità e precisione, o nel comprendere rapidamente ciò che leggono. Queste difficoltà emergono nonostante un’adeguata istruzione, un’intelligenza nella norma e l’assenza di problematiche sensoriali o neurologiche.
Spiegato in modo semplice, essere dislessici significa elaborare il linguaggio scritto in modo diverso rispetto alla media. Non si tratta di una malattia, né tantomeno di un indicatore di minore capacità cognitiva; il cervello della persona dislessica funziona perfettamente, ma adotta strategie neurali differenti per leggere, scrivere e organizzare le informazioni linguistiche.
Il significato della dislessia va quindi compreso nel suo contesto: si tratta di una neurodiversità che può influenzare il percorso scolastico, la vita professionale e l'autostima, soprattutto se non viene riconosciuta precocemente.
Con una diagnosi accurata e strategie mirate, bambini, adolescenti e adulti dislessici possono apprendere con successo, valorizzando le proprie potenzialità e affrontando le sfide in modo efficace.
Comprendere cosa vuol dire essere dislessici è il primo passo per garantire il giusto supporto, creare ambienti inclusivi e promuovere un apprendimento più equo per tutti. La dislessia non definisce chi sei: è solo uno dei tanti modi in cui il cervello umano può funzionare.
Quali sono le caratteristiche principali della dislessia?
Riconoscere la dislessia può non essere immediato, soprattutto nei primi anni di scuola, quando ogni bambino ha i propri tempi di apprendimento. Tuttavia, ci sono caratteristiche ricorrenti che possono aiutarci ad individuare segnali da non sottovalutare. Quando un bambino, o anche un adulto, mostra difficoltà nella lettura che persistono nel tempo nonostante l’impegno, è utile fermarsi e osservare più da vicino.
Tra i sintomi della dislessia più frequenti troviamo:
- Lettura lenta, faticosa e poco accurata: il bambino può impiegare molto tempo per leggere anche testi semplici, interrompendosi spesso, scandendo le sillabe o rileggendo più volte le stesse parole.
- Errori frequenti nella decodifica delle parole: tra gli indizi più tipici ci sono le inversioni di lettere (es. leggere “b” al posto di “d”), omissioni di lettere o sillabe, oppure aggiunte che alterano la parola.
- Difficoltà a comprendere ciò che legge: l’energia mentale richiesta per decodificare il testo può lasciare poche risorse per capirne il significato. Questo porta a una scarsa comprensione del testo, anche quando il bambino riesce a leggerlo tutto.
- Difficoltà a tenere il passo della classe: anche con grande impegno, questi studenti possono sembrare “più lenti” o “distratti”, mentre in realtà stanno lottando con un processo più complesso.
- Intelligenza nella norma o superiore alla media: molti dislessici dimostrano una notevole capacità di ragionamento, creatività, pensiero visivo e intuito. Proprio per questo motivo, spesso le loro difficoltà possono passare inosservate o essere interpretate in modo errato.
Questi segnali non vanno letti come diagnosi, ma come spie di attenzione. Se tuo figlio (o tu stesso) mostra uno o più di questi comportamenti, può essere utile parlarne con un insegnante, uno psicologo o un logopedista, per approfondire con strumenti adeguati.
Capire cosa significa leggere con difficoltà, senza perdere fiducia nelle proprie capacità, è il primo passo verso un percorso di supporto efficace e personalizzato. La diagnosi precoce permette di attivare strategie che possono fare davvero la differenza, sia a scuola che nella vita quotidiana.
Dislessia e DSA: qual è la differenza?
Quando parliamo di DSA, ovvero, ricordiamolo, di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ci riferiamo a un insieme di condizioni che riguardano in modo specifico alcune abilità scolastiche fondamentali: lettura, scrittura e calcolo. La dislessia è sicuramente il disturbo più noto, ma non è l’unico. È importante conoscere le differenze tra i vari DSA, perché ciascuno di essi ha caratteristiche proprie e richiede interventi mirati.
La dislessia è il disturbo che riguarda la lettura. Le persone dislessiche faticano a leggere in modo fluido, veloce e accurato. Possono avere difficoltà a riconoscere le parole, a decodificare i suoni, a leggere ad alta voce o a comprendere ciò che leggono. È come se ogni parola richiedesse uno sforzo aggiuntivo per essere "letta" correttamente.
La disortografia, invece, riguarda la correttezza della scrittura. I bambini e gli adulti con disortografia tendono a fare molti errori ortografici, anche nelle parole semplici. Possono confondere lettere simili, omettere o aggiungere lettere o sillabe, o scrivere una stessa parola in modi diversi nello stesso testo.
La disgrafia coinvolge la scrittura a mano. Chi è disgrafico può avere una calligrafia poco leggibile, con difficoltà nel mantenere una forma chiara e regolare delle lettere, una spaziatura adeguata e un controllo fluido del gesto grafico. Spesso la scrittura risulta lenta e faticosa.
La discalculia è il disturbo legato alla capacità di calcolo e gestione dei numeri. Può manifestarsi con difficoltà nel riconoscere i numeri, nell’eseguire operazioni aritmetiche di base, nel memorizzare le tabelline o nel comprendere i concetti matematici.
Tutti questi disturbi condividono una caratteristica fondamentale: non dipendono da mancanza di intelligenza o di impegno, e si manifestano nonostante un ambiente scolastico adeguato e normali opportunità di apprendimento. Riguardano esclusivamente alcune abilità specifiche e non l’intero funzionamento cognitivo.
Comprendere che la dislessia è solo uno dei DSA è importante per evitare confusioni e per fornire alle persone il supporto più adeguato. Ogni disturbo richiede strategie personalizzate che tengano conto delle difficoltà, ma anche delle risorse e dei punti di forza dell’individuo.

Quanti tipi di dislessia esistono?
La dislessia non si manifesta allo stesso modo in tutte le persone. Sebbene ogni individuo abbia un profilo unico, nella pratica clinica vengono generalmente identificate tre forme principali di dislessia. Queste categorie non servono ad "etichettare", ma ad aiutare i professionisti a comprendere meglio le difficoltà specifiche della persona e a proporre interventi su misura.
Dislessia fonologica
È la forma più comune nei bambini in età scolare: chi presenta questo tipo di dislessia ha difficoltà nel riconoscere e manipolare i suoni all’interno delle parole. Ad esempio, può faticare a “spezzare” una parola in sillabe o a trasformare una parola cambiando una lettera. La lettura risulta molto faticosa, soprattutto con parole nuove o mai viste prima, perché manca una buona base di “decodifica fonemica” (cioè la capacità di trasformare lettere in suoni).
Dislessia superficiale
In questo caso la difficoltà principale riguarda la lettura globale delle parole, soprattutto quelle che non si leggono “come si scrivono” (parole irregolari, eccezioni ortografiche). Le persone con dislessia superficiale tendono a leggere tutto “lettera per lettera” e possono fare errori con parole comuni che non seguono le regole fonetiche. Questo tipo di difficoltà può emergere più tardi, anche in bambini più grandi o in adulti.
Dislessia mista (o profonda)
È una combinazione delle due forme precedenti: chi ha una dislessia mista può presentare difficoltà sia nel riconoscere i suoni delle parole, sia nel leggere globalmente. Questo può rendere la lettura particolarmente impegnativa e influenzare anche la comprensione del testo.
Riconoscere il tipo di dislessia non ha lo scopo di classificare la persona, ma di costruire strategie personalizzate per migliorare la lettura e sostenere l’autonomia nello studio. Sapere se si tratta di una dislessia fonologica, superficiale o mista permette di scegliere gli strumenti giusti, dai programmi di potenziamento alle tecnologie compensative, fino all’approccio didattico più adatto.
Come riconoscere i sintomi della dislessia nei bambini?
Una delle domande più frequenti che ricevo da genitori e insegnanti è: “Come faccio a capire se mio figlio è dislessico?”. La verità è che riconoscere la dislessia nei bambini, soprattutto nei primi anni della scuola primaria, non è sempre semplice.
Ogni bambino ha tempi di apprendimento diversi, e alcuni errori possono essere del tutto normali in una fase iniziale.
Tuttavia, esistono alcuni segnali specifici che possono accendere un campanello d’allarme e che è importante non sottovalutare, soprattutto se persistono nel tempo.
Un bambino con segnali di dislessia può:
- Leggere lentamente e con fatica: può impiegare molto tempo a leggere una singola frase, spezzando le parole sillaba per sillaba, e apparire affaticato già dopo pochi minuti.
- Saltare lettere o sillabe durante la lettura: può leggere “casa” come “asa”, oppure “cane” come “cne”.
- Avere difficoltà a copiare dalla lavagna: il passaggio dallo stimolo visivo alla scrittura può essere complicato, causando frequenti errori o lentezza.
- Confondere lettere simili, come “p” e “b” o “d” e “q”, soprattutto durante la scrittura o la lettura ad alta voce.
- Evitare di leggere davanti agli altri: alcuni bambini sviluppano un vero e proprio disagio emotivo legato alla lettura e cercano di evitare situazioni in cui si sentono esposti.
Questi comportamenti non equivalgono a una diagnosi, ma rappresentano indicazioni importanti che meritano attenzione. È utile osservarli con continuità e parlarne con le figure scolastiche di riferimento o con uno psicologo specializzato in disturbi dell’apprendimento. Solo una valutazione professionale può chiarire se si tratta davvero di dislessia.
Riconoscere i sintomi della dislessia nei bambini in modo precoce è fondamentale, perché permette di intervenire in tempi utili, attivando percorsi didattici e psicologici che aiutano il bambino a recuperare fiducia e ad imparare grazie all’ausilio di strumenti adatti a lui.
Quali sono i segnali precoci della dislessia nella scuola primaria?
La dislessia tra i 6 e i 9 anni può manifestarsi attraverso segnali ben precisi, che è importante saper riconoscere durante i primi anni della scuola primaria. In questa fase, i bambini dovrebbero iniziare a leggere con sempre maggiore autonomia, rapidità e comprensione.
Quando questo processo appare più lento o faticoso del previsto, è utile prestare attenzione, come abbiamo detto, ad alcuni comportamenti ricorrenti.
Tra i segnali più frequenti ricordiamo:
- Una lettura lenta e poco fluida, con pause frequenti, sillabazione di parole semplici o necessità di rileggere più volte lo stesso passaggio.
- Errori anche su parole familiari, come leggere “casa” al posto di “cassa”, o invertire lettere all’interno di una parola.
- Difficoltà a seguire il ritmo della classe, in particolare durante le attività di lettura e scrittura, con tempi più lunghi per completare i compiti o frequenti perdite di concentrazione.
- Confusione tra lettere simili, come “p” e “b”, “d” e “q”, oppure difficoltà a copiare correttamente dalla lavagna.
- Errori ortografici ripetuti, che si mantengono anche dopo averli corretti più volte.
- Tendenza ad evitare la lettura ad alta voce, rifiutandosi o mostrando disagio quando viene chiesto di leggere davanti agli altri.
In presenza di queste difficoltà, il bambino può iniziare a mettere in discussione le proprie capacità, mostrando segnali di frustrazione, disinteresse o demotivazione. In alcuni casi, compaiono anche comportamenti difensivi o evitanti, che non vanno interpretati come “svogliatezza”, ma come possibili indicatori di un disagio reale.
Questi segnali non permettono una diagnosi autonoma, ma rappresentano indizi utili per approfondire la situazione con l’aiuto di un professionista. Intercettare precocemente le difficoltà di lettura permette di offrire al bambino strategie di supporto efficaci e restituirgli fiducia nel proprio percorso scolastico.
Cosa fare se si sospetta la dislessia in un bambino?
Se hai notato alcuni segnali che ti fanno sospettare la presenza di dislessia, il primo passo importante è non rimanere soli con il dubbio. Parlane con le figure che conoscono bene tuo figlio, come gli insegnanti, che possono offrire un punto di vista utile basato sull’osservazione quotidiana in classe.
Anche il pediatra di base è un riferimento fondamentale: potrà valutare se è opportuno approfondire e indirizzarti verso uno psicologo dell’età evolutiva o verso una struttura specializzata nella valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
La valutazione per la dislessia è un processo serio e approfondito, che non si basa su una semplice impressione o su un test rapido. Si tratta di un percorso clinico che prevede:
- Colloqui con i genitori e, spesso, con gli insegnanti, per raccogliere informazioni sullo sviluppo e sul funzionamento scolastico del bambino.
- Osservazione diretta e somministrazione di test standardizzati, utili a valutare il profilo cognitivo, le abilità di lettura, scrittura e comprensione.
- Analisi dei risultati, da parte di uno psicologo esperto in diagnosi DSA, che redigerà una relazione chiara, utile per l’eventuale attivazione di supporti scolastici.
Questo percorso serve a capire se si tratta effettivamente di dislessia e, in caso positivo, a descrivere le caratteristiche specifiche del bambino, così da poter progettare un intervento personalizzato.
Agire presto fa davvero la differenza: una diagnosi precoce permette non solo di evitare che il bambino accumuli frustrazione o senso di inadeguatezza, ma anche di attivare strategie didattiche e psicologiche che lo aiutino a ritrovare fiducia, motivazione e autonomia nello studio. In molti casi, è proprio il riconoscimento tempestivo a cambiare radicalmente l’esperienza scolastica.
Come si manifesta la dislessia negli adulti?
Hai sempre avuto difficoltà con la lettura veloce, ma col tempo hai imparato a cavartela comunque? Ti capita di sentirti insicuro quando devi scrivere un’e-mail importante, leggere un testo ad alta voce o parlare in pubblico, anche se conosci l’argomento?
Potresti aver convissuto, senza saperlo, con una dislessia non diagnosticata.
Molti adulti scoprono solo in età avanzata di essere dislessici. Da bambini, le difficoltà magari erano attribuite a scarsa attenzione, svogliatezza o ansia. Oppure, semplicemente, si è imparato a compensare: più tempo per studiare, lettura ad alta voce solo in privato, appunti visivi, supporto da parte di amici o colleghi.
Ma sotto queste strategie può essere rimasta una fatica costante, una sensazione di frustrazione, o il pensiero persistente di “fare più fatica degli altri per ottenere gli stessi risultati”.
I sintomi della dislessia negli adulti possono essere diversi da quelli dell’infanzia. Alcuni esempi:
- Lettura lenta, anche su testi semplici
- Difficoltà a seguire righe o colonne di un documento
- Errori di ortografia o impaccio nella scrittura formale
- Difficoltà a gestire informazioni scritte complesse (manuali, regolamenti)
- Evitamento di contesti che richiedano lettura pubblica o esposizione verbale
In ambito universitario o lavorativo, la dislessia non diagnosticata può influire sulla fiducia in sé, sulla gestione del tempo, sulla capacità di affrontare situazioni nuove. Ma è importante sapere che non è mai troppo tardi per capirsi meglio: oggi esistono strumenti anche per gli adulti, e ricevere una valutazione da parte di uno psicologo può portare sollievo, spiegazioni e nuove strategie.
Riconoscere che alcune difficoltà hanno un nome — dislessia — non serve ad etichettare, ma ad aprire nuove possibilità; non per cambiare il passato, ma per migliorare il presente.
Quali difficoltà può incontrare un adulto dislessico?
È possibile che la dislessia in età adulta si manifesti in modi diversi rispetto all’infanzia, ma resta presente, e spesso si intreccia, con il vissuto personale e professionale della persona. Molti adulti dislessici hanno imparato a “mascherare” le proprie difficoltà, trovando strategie alternative e adattandosi alle richieste della vita quotidiana. Tuttavia, alcuni segnali restano, soprattutto nei contesti più formali o cognitivamente impegnativi.
Ecco alcuni esempi pratici di come la dislessia possa presentarsi nella vita adulta:
- Lettura lenta e faticosa, soprattutto di testi lunghi, regolamenti, contratti o documenti accademici. Anche leggere un semplice libro può richiedere molto tempo e concentrazione.
- Difficoltà nella scrittura formale, come scrivere una mail di lavoro, un curriculum o una relazione. Può esserci incertezza su come impostare il testo, su ortografia e punteggiatura, oppure un timore costante di “fare brutta figura”.
- Insicurezza nel parlare in pubblico, specialmente in situazioni valutative come esami universitari, colloqui di lavoro o presentazioni. L’ansia può crescere per la paura di leggere male, dimenticare parole o essere giudicati poco preparati.
- Difficoltà sul lavoro o nello studio universitario, dove è richiesto di gestire molte informazioni scritte, rispettare scadenze, organizzare documenti o partecipare attivamente a riunioni.
- Sensazione di inadeguatezza o frustrazione, anche in persone molto competenti, che si sentono però “meno brillanti” o “sempre un passo indietro” rispetto agli altri.
Ma non c’è solo il lato difficile: molti adulti con dislessia sviluppano nel tempo abilità fuori dal comune in aree come la creatività, il pensiero laterale, l’intuito, la capacità di problem solving. La mente dislessica spesso lavora in modo più visivo e sistemico, con una naturale predisposizione a trovare soluzioni originali o collegare idee in modo non convenzionale.
Riconoscere queste caratteristiche non solo aiuta a normalizzare le difficoltà, ma anche a valorizzare i punti di forza che spesso passano inosservati.

È possibile avere una dislessia non diagnosticata?
Sì, è più comune di quanto si pensi: molti adulti dislessici non riconosciuti hanno convissuto per anni con le loro difficoltà senza mai ricevere una diagnosi formale. In molti casi, queste persone hanno sviluppato strategie compensative efficaci: affidarsi alla memoria, usare schemi visivi, organizzarsi in modo preciso, chiedere supporto, evitare determinate situazioni. Queste risorse personali hanno permesso loro di andare avanti — a scuola, all’università, nel lavoro — ma spesso a costo di grande fatica, ansia o insicurezza.
La verità è che riconoscere la dislessia in età adulta non è “tardi”: è un passo importante verso una maggiore consapevolezza di sé. Scoprirlo può dare senso a molte esperienze passate, come le difficoltà a scuola mai comprese, il disagio durante le interrogazioni, il senso di inadeguatezza davanti a una semplice lettura in pubblico, o le fatiche nel gestire scrittura e organizzazione del lavoro.
Intraprendere oggi un percorso di valutazione non significa cercare un’etichetta, ma guardarsi con occhi nuovi, accettando che quel modo di leggere, scrivere o studiare non era “sbagliato” — era semplicemente diverso.
E da qui può nascere qualcosa di nuovo: strategie mirate, strumenti compensativi adeguati, ma anche un senso di liberazione e riconciliazione con il proprio percorso.
Non è mai troppo tardi per comprendersi meglio e alleggerire il peso di difficoltà che, per troppo tempo, sono rimaste invisibili.
Come diagnosticare la dislessia?
Ricevere una diagnosi di dislessia è un passaggio importante, sia per i bambini che per gli adulti, perché significa comprendere come funziona il suo modo di apprendere e offrire gli strumenti giusti per supportarlo, a scuola, nel lavoro o nella vita quotidiana.
Molti genitori si chiedono: “A chi devo rivolgermi?” oppure “Basta un test online per capirlo?”. Sono domande comprensibili. La risposta è che, per avere un quadro affidabile e completo, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati, all’interno di un percorso clinico strutturato.
Nel caso di un sospetto di dislessia, il primo passo è parlarne con un insegnante, con il pediatra o con uno psicologo dell’età evolutiva, che potrà indicare il percorso più adatto.
Anche gli adulti che si riconoscono nei sintomi possono rivolgersi a specialisti in disturbi dell’apprendimento per approfondire la situazione.
Capire se si è dislessici — anche da grandi — può dare un senso a tante difficoltà vissute nel tempo, e soprattutto aprire la strada a nuove possibilità di apprendimento, benessere e realizzazione personale.
A chi rivolgersi per una valutazione?
La diagnosi di dislessia è un passaggio delicato e importante, e può essere effettuata solo da professionisti qualificati, in grado di condurre una valutazione completa, che tenga conto di diversi aspetti dello sviluppo e dell’apprendimento.
Questo tipo di percorso coinvolge solitamente più figure: lo psicologo specializzato in età evolutiva o nei disturbi specifici dell’apprendimento, il neuropsichiatra infantile, che valuta il quadro clinico generale e lo sviluppo neurologico, e il logopedista, che si occupa di approfondire le competenze linguistiche e scolastiche, in particolare lettura, scrittura e linguaggio.
Queste figure lavorano in modo integrato, formando quella che viene chiamata équipe multidisciplinare, indispensabile per una valutazione completa e attendibile.
Per accedere a una valutazione, si può scegliere di rivolgersi al servizio pubblico — come l’ASL, un ospedale o un consultorio — oppure a un professionista privato accreditato. Le strutture pubbliche offrono un servizio gratuito o con un ticket sanitario, anche se i tempi d’attesa possono essere piuttosto lunghi. In compenso, la certificazione rilasciata ha valore legale ed è sempre riconosciuta dalla scuola.
Chi preferisce evitare tempi lunghi può rivolgersi a uno psicologo privato o a un centro clinico autorizzato dalla propria regione. In questo caso, la valutazione è a pagamento, ma può avvenire in tempi più brevi. È importante verificare che il professionista sia abilitato al rilascio di certificazioni riconosciute: solo così sarà possibile presentare la documentazione a scuola per ottenere i dovuti supporti.
Una volta completata la diagnosi, se viene confermata la presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, viene rilasciata una certificazione ufficiale. Questo documento permette alla scuola di attivare un PDP (Piano Didattico Personalizzato): uno strumento fondamentale per garantire al bambino o al ragazzo le misure di supporto più adatte, nel rispetto della normativa vigente.
Test online e diagnosi clinica: cosa sapere?
Online si trovano molti test per la dislessia, spesso gratuiti, veloci e di facile accesso. È comprensibile che un genitore o un adulto in cerca di risposte possa sentirsi attratto da queste soluzioni immediate.
È fondamentale chiarire un punto: questi test non sono strumenti diagnostici, ma solo strumenti orientativi. Possono aiutare a riflettere sui propri dubbi, ma non possono in alcun modo sostituire una valutazione clinica completa.
Una diagnosi ufficiale di dislessia deve essere effettuata da un’équipe di professionisti formati, attraverso un percorso rigoroso e validato scientificamente. Questo percorso include:
- Colloqui clinici, con i genitori (nel caso dei bambini) o con la persona adulta, per raccogliere la storia evolutiva, scolastica e personale;
- Osservazione del comportamento durante le prove, utile per comprendere le strategie adottate, il livello di affaticamento, l’ansia, la motivazione;
- Test standardizzati, ovvero strumenti specifici utilizzati per misurare con precisione:
- la velocità e correttezza nella lettura;
- la comprensione del testo;
- le abilità di scrittura e ortografia;
- il funzionamento cognitivo generale (memoria, attenzione, linguaggio...).
Solo un’équipe specializzata è in grado di interpretare questi risultati in modo integrato, confrontandoli con i parametri normativi ed escludendo la presenza di altre possibili cause (come difficoltà emotive, momenti di stress, o disturbi transitori).
In sintesi: se hai un dubbio, un test online può essere un punto di partenza, ma non basta per trarre conclusioni. Per sapere davvero se si tratta di dislessia — e in che forma — serve affidarsi a una valutazione psicodiagnostica seria e professionale.
Bambini, ragazzi o adulti: la dislessia può essere gestita con il giusto aiuto.
Trova lo psicologo più adatto alle tue esigenze su psicologodibase.com e riprendi il controllo del tuo apprendimento.
Dislessia e scuola: cosa fare per aiutare un alunno con DSA?
Quando un bambino riceve una diagnosi di dislessia, è naturale che genitori e insegnanti si pongano subito una domanda fondamentale:
“E adesso cosa succede a scuola?”
La buona notizia è che il sistema scolastico italiano prevede tutele specifiche per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Grazie alla Legge 170/2010, ogni alunno con una certificazione di dislessia ha diritto a un percorso scolastico personalizzato, inclusivo e rispettoso delle sue caratteristiche di apprendimento.
Questo significa che, una volta ricevuta la certificazione, la scuola attiva un documento chiamato PDP (Piano Didattico Personalizzato). Si tratta di uno strumento pratico e condiviso tra scuola, famiglia e specialisti, che definisce:
- Quali strumenti compensativi utilizzare (ad esempio: sintesi vocale, mappe concettuali, audiolibri...);
- Quali misure dispensative applicare (ad esempio: meno letture ad alta voce, più tempo nelle verifiche, modalità alternative di valutazione);
- Quali strategie didattiche adottare per rendere l’apprendimento più efficace e accessibile.
Tutto questo non serve a “facilitare” il bambino, ma a metterlo nelle condizioni di esprimere davvero il proprio potenziale, senza essere penalizzato da difficoltà che non dipendono dalla sua volontà.
Ricevere una diagnosi, quindi, non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: quello di un percorso educativo più consapevole, costruito attorno alle reali esigenze del bambino. La collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti è fondamentale per far sì che il bambino non si senta diverso, ma semplicemente compreso.
Cosa prevede la legge 170/2010?
Quando un bambino riceve una diagnosi di dislessia, è importante sapere che la legge italiana tutela in modo chiaro i suoi diritti scolastici. La Legge 170/2010 riconosce ufficialmente i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e stabilisce che la scuola ha il dovere di garantire un percorso didattico accessibile, equo e rispettoso delle caratteristiche individuali dell’alunno.
Questo significa che gli insegnanti devono:
- Adottare strumenti compensativi, cioè strumenti che aiutano l’alunno a studiare e lavorare con maggiore autonomia. Alcuni esempi sono: mappe concettuali, libri digitali, sintesi vocale, calcolatrici, formulari;
- Applicare misure dispensative, ovvero esenzioni mirate da alcune prestazioni che risulterebbero particolarmente penalizzanti, come leggere ad alta voce in classe, copiare dalla lavagna o svolgere prove scritte troppo lunghe;
- Redigere un PDP (Piano Didattico Personalizzato), un documento condiviso con la famiglia e gli specialisti, che definisce con chiarezza gli strumenti, i tempi, e le modalità di verifica più adatte allo studente.
Tutto questo non è un’opzione, ma un obbligo previsto dalla normativa. L’obiettivo non è “semplificare” il percorso scolastico, ma garantire pari opportunità e prevenire l’insorgere di frustrazione, senso di inadeguatezza o demotivazione.
Immagina, ad esempio, un bambino con dislessia che fatica a leggere rapidamente: costringerlo a leggere ad alta voce davanti alla classe non solo non migliora la sua competenza, ma può aumentare ansia e vergogna.
Grazie alle tutele previste dalla legge, la scuola può offrire modalità alternative, come l’uso dell’audiolibro o il tempo aggiuntivo nelle verifiche, che permettono al bambino di esprimere il proprio potenziale senza essere penalizzato dalla difficoltà specifica.
Conoscere e applicare la normativa DSA è fondamentale per costruire una scuola realmente inclusiva, dove ogni studente si senta accolto, rispettato e messo nelle condizioni di apprendere con serenità.
Cos’è un PDP e quali strumenti compensativi sono previsti?
Il PDP, ovvero Piano Didattico Personalizzato, è un documento fondamentale per garantire a ogni studente con dislessia un percorso scolastico equo e su misura. Non è un modulo precompilato, ma un piano costruito con attenzione, che descrive in modo chiaro e condiviso come adattare la didattica alle esigenze specifiche dell’alunno.
Il PDP viene redatto in collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti, dopo la presentazione della certificazione di dislessia. Deve essere approvato all’inizio di ogni anno scolastico e può essere aggiornato nel tempo, in base all’evoluzione del percorso di apprendimento.
Cosa contiene un PDP?
- Le caratteristiche del disturbo e come si manifesta nel contesto scolastico;
- Gli obiettivi didattici personalizzati, mantenendo gli stessi contenuti degli altri alunni, ma con modalità di lavoro più accessibili;
- Gli strumenti compensativi che aiutano lo studente a superare le difficoltà legate alla lettura e alla scrittura;
- Le misure dispensative, ovvero esenzioni da alcune attività che risulterebbero eccessivamente faticose o non funzionali all’apprendimento.
Esempi di strumenti compensativi per la dislessia:
- Sintesi vocale, per ascoltare i testi invece di leggerli;
- Mappe concettuali o schemi visivi, per organizzare meglio le informazioni;
- Calcolatrice, formulari o tabelle per supportare il lavoro matematico;
- Computer o tablet per scrivere in modo più fluido e ordinato.
Esempi di misure dispensative:
- Più tempo per completare verifiche e compiti;
- Esenzione dalla lettura ad alta voce in classe;
- Riduzione del numero di esercizi scritti;
- Valutazioni orali in alternativa a quelle scritte, quando possibile.
Il PDP non è un favore, ma un diritto riconosciuto dalla normativa sui DSA. Serve a garantire che l’alunno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità, senza essere penalizzato dalle difficoltà specifiche legate alla dislessia. È uno strumento di equità, non di vantaggio.

Strategie pratiche per studiare con la dislessia
La diagnosi è solo l’inizio di un percorso. Una volta compreso che la difficoltà nella lettura o nello studio ha un nome, il passo successivo è trovare strategie personalizzate che rendano l’apprendimento più accessibile ed efficace. È in questa fase che può davvero emergere un cambiamento significativo.
Per ogni età e contesto di vita, esistono strumenti e metodi che possono fare la differenza. Un bambino con dislessia può trarre grande beneficio da tecniche visive, sintesi vocale, o dal supporto di mappe concettuali. Un adolescente può imparare a organizzare lo studio in modo più funzionale, magari suddividendo i compiti in tempi brevi e alternando pause regolari. Un adulto che torna a studiare, magari per un esame universitario o una nuova qualifica professionale, può finalmente alleggerire il carico mentale grazie a strategie nuove e più consapevoli.
Non si tratta di “recuperare” qualcosa che manca, ma di scoprire un proprio modo di apprendere che sia più naturale, più sostenibile e meno frustrante. Il supporto di un professionista – uno psicologo dell’apprendimento, un tutor specializzato o un educatore – può essere determinante per individuare le strategie più adatte, rafforzare la motivazione e far sì che lo studio non sia più un ostacolo, ma un’opportunità di crescita.
Tecniche di studio e strumenti utili
Alcune strategie di studio, semplici ma mirate, possono davvero fare la differenza per chi ha una diagnosi di dislessia. Non si tratta di “semplificare”, ma di adattare il modo di apprendere alle caratteristiche cognitive della persona, rendendo lo studio più accessibile ed efficace.
Per esempio, l’uso di mappe mentali o concettuali consente di visualizzare le informazioni in modo più chiaro e organizzato, facilitando la comprensione e la memorizzazione. Leggere con l’aiuto di evidenziatori colorati o righelli trasparenti può aiutare a mantenere l’attenzione e non perdere il segno tra le righe.
Anche audiolibri e podcast rappresentano strumenti preziosi: permettono di accedere ai contenuti attraverso il canale uditivo, spesso più efficace per chi ha difficoltà nella lettura prolungata. Insieme a questi, le app progettate per i DSA, come LeggiXme o SuperQuaderno, offrono funzioni di sintesi vocale, scrittura facilitata e supporti visivi che aiutano lo studente ad affrontare testi complessi con maggiore autonomia.
Un altro aspetto importante riguarda la gestione del tempo. Suddividere lo studio in blocchi brevi e regolari, intervallati da pause frequenti, può migliorare la concentrazione e ridurre il senso di fatica, spesso accentuato nei bambini e ragazzi con dislessia.
Il ruolo del genitore è fondamentale, perché anche senza competenze tecniche, può supportare attivamente il proprio figlio leggendo ad alta voce insieme, aiutandolo a costruire mappe concettuali a voce o con disegni, e soprattutto rafforzando la motivazione attraverso incoraggiamento e riconoscimento dei progressi.
Adottare queste strategie non significa “fare di meno”, ma fare in modo diverso, nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno. E proprio questa personalizzazione, quando ben costruita, può restituire fiducia, autonomia e soddisfazione nello studio.
Come sostenere l’autonomia e l’autostima?
La dislessia non è solo una difficoltà legata alla lettura o alla scrittura: ha spesso un impatto anche sul piano emotivo e psicologico. Un bambino che fatica a tenere il passo con la classe, che si confronta ogni giorno con errori, lentezza o incomprensioni, può iniziare a percepirsi come “diverso” o “incapace”. Questo vissuto, se non riconosciuto e accompagnato, può dare origine a emozioni negative come insicurezza, frustrazione e bassa autostima.
Lo stesso accade negli adulti con dislessia non diagnosticata, che per anni hanno affrontato la scuola o il lavoro sentendosi “meno intelligenti” o “fuori posto”, spesso senza riuscire a dare un nome alle proprie difficoltà. In entrambi i casi, il rischio è che la dislessia venga vissuta come un limite personale, piuttosto che come una diversa modalità di apprendere.
Per questo, sostenere chi ha la dislessia significa anche lavorare sull’autonomia e sull’autostima. Aiutare un bambino a usare in modo indipendente gli strumenti di supporto – come una sintesi vocale, una mappa concettuale, un’app per l’organizzazione dello studio – è fondamentale, ma da solo non basta. È importante, ad esempio, valorizzare i piccoli successi quotidiani, rinforzare i progressi e incoraggiare la perseveranza, anche davanti alle difficoltà.
Frasi semplici come:
“Hai fatto tutto da solo”,
“Hai trovato il tuo metodo”,
“Non ti sei arreso anche se era difficile”
possono sembrare banali, ma hanno un impatto profondo. Comunicano fiducia, riconoscimento, e rafforzano il senso di competenza, che è alla base di una buona autostima.
È fondamentale anche ricordare che chi ha la dislessia possiede spesso grandi risorse personali. Non è raro trovare in questi bambini e adulti un pensiero creativo vivace, una spiccata intelligenza emotiva, una forte capacità di problem solving, oppure un modo originale di osservare il mondo. Riconoscere e valorizzare questi punti di forza significa offrire un’immagine positiva di sé, in cui la dislessia non è un’etichetta limitante, ma una parte della propria identità – con sfide, sì, ma anche con potenzialità uniche.
Domande frequenti sulla dislessia (FAQ)
A che età si può diagnosticare la dislessia?
La dislessia può essere diagnosticata in modo affidabile dalla fine della seconda elementare, intorno ai 7–8 anni; a questa età, le abilità di lettura e scrittura sono sufficientemente sviluppate da permettere una valutazione clinica precisa.
Tuttavia, alcuni segnali di rischio possono emergere anche prima, già tra i 5 e i 6 anni. In questi casi non si parla ancora di diagnosi, ma è possibile osservare difficoltà nel riconoscere i suoni delle parole, nel ricordare sequenze o nel nominare rapidamente oggetti. Raccogliere queste prime osservazioni è importante, perché permette di intervenire precocemente con strategie educative mirate, che possono aiutare il bambino ad affrontare l’apprendimento in modo più sereno.
Quindi, la diagnosi ufficiale arriva dopo i 7 anni, ma l’ascolto e l’attenzione cominciano molto prima.
La dislessia si può curare o migliorare?
No, la dislessia non si “guarisce”, perché non è una malattia. È una caratteristica del modo in cui funziona il cervello, legata alla lettura e alla scrittura. Tuttavia, la buona notizia è che si può imparare a gestirla molto bene.
Con il giusto supporto, è possibile migliorare in modo significativo: bambini, ragazzi e adulti possono potenziare le proprie abilità grazie a strategie personalizzate, strumenti digitali pensati per i DSA, un metodo di studio efficace e un ambiente scolastico o lavorativo che valorizzi le risorse individuali.
Un percorso mirato, costruito con professionisti competenti, può aiutare la persona a ridurre le difficoltà, aumentare l’autonomia nello studio e, soprattutto, rafforzare la fiducia in sé stessa.
Qual è la differenza tra dislessia e difficoltà di lettura temporanee?
È del tutto normale che molti bambini, specie nei primi anni della scuola primaria, attraversino un periodo di difficoltà nella lettura, spesso si tratta di un passaggio temporaneo legato all’adattamento ai nuovi apprendimenti o a ritmi diversi tra un bambino e l’altro.
Tuttavia, quando le difficoltà persistono nel tempo, non migliorano nonostante un insegnamento adeguato e si associano ad altri segnali, può essere utile approfondire con una valutazione.
La dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento: una condizione persistente, specifica e non dipendente dall’intelligenza o dalla volontà del bambino; questo significa che anche bambini brillanti e motivati possono avere una dislessia che ostacola il loro percorso scolastico, in particolare nella lettura e nella scrittura.
Le difficoltà di lettura temporanee sono legate a fattori momentanei come stanchezza o ritmi diversi di apprendimento.
Capire la differenza tra una difficoltà passeggera e un disturbo come la dislessia è importante per offrire il giusto supporto e prevenire frustrazioni o cali di autostima.
Un adulto può scoprire di essere dislessico solo in età avanzata?
Sì, è possibile, e accade spesso.
Molti adulti dislessici non diagnosticati si accorgono solo con il tempo di aver sempre avuto difficoltà nella lettura, nella scrittura o nella gestione delle informazioni. Spesso hanno compensato con strategie personali, senza sapere di avere un disturbo specifico dell’apprendimento.
Scoprire oggi di essere dislessici può dare senso a fatiche vissute fin dall’infanzia e aiutare a trovare strategie più efficaci per affrontare studio, lavoro o vita quotidiana. Una diagnosi in età adulta permette di riconoscere il proprio stile cognitivo, valorizzare i punti di forza e superare il senso di inadeguatezza.
Riconoscersi è il primo passo per stare meglio, non solo nello studio, ma anche nell’autostima.
Che relazione c’è tra dislessia e ADHD?
Dislessia e ADHD possono coesistere, ma si tratta di disturbi distinti, con caratteristiche differenti. La dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento legato alla decodifica della lettura: chi ne è affetto può leggere lentamente, con errori o difficoltà nella comprensione del testo. L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), invece, coinvolge la capacità di mantenere l’attenzione, regolare l’impulsività e gestire l’iperattività.
Quando queste due condizioni si presentano insieme (comorbidità), possono rendere il percorso scolastico più impegnativo: ad esempio, uno studente potrebbe faticare sia a leggere con precisione che a restare concentrato sul compito.
Quali strumenti digitali aiutano chi ha la dislessia nello studio o al lavoro?
App di sintesi vocale, mappe concettuali digitali, audiolibri e software per la scrittura facilitata supportano l’apprendimento e la produttività.
La dislessia influisce solo sulla lettura o anche sulla scrittura e sul calcolo?
La dislessia riguarda la lettura, ma può essere associata ad altri DSA come disortografia o discalculia, influenzando anche scrittura e matematica.
Un genitore può riconoscere i segnali di dislessia già nella scuola dell’infanzia?
Sì, difficoltà nel riconoscere i suoni, ricordare sequenze o nominare rapidamente oggetti possono essere campanelli d’allarme precoci.
La dislessia si può “curare” o si impara a gestirla con strategie mirate?
La dislessia non si cura perché non è una malattia, ma si gestisce con strategie personalizzate e strumenti compensativi efficaci.
Quali professionisti possono fare diagnosi di dislessia e come scegliere quello giusto?
La diagnosi è effettuata da un’équipe di psicologo, logopedista e neuropsichiatra infantile; è importante rivolgersi a centri accreditati e qualificati.
Con una diagnosi accurata, strumenti adeguati e strategie personalizzate, è possibile affrontare qualsiasi difficoltà con efficacia. Lavoriamo insieme per rafforzare le tue capacità con un percorso di psicoterapeuta individuale e trasforma le difficoltà in opportunità di crescita